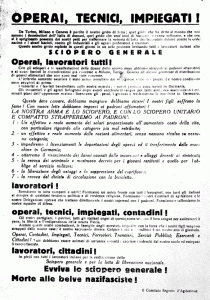L’1 marzo 1944 migliaia di operai in tutto il Nord Italia scesero in sciopero spinti soprattutto dalle precettazioni obbligatorie in Germania. Non fu il primo sciopero verificatosi dalla nascita della Repubblica Sociale Italiana (RSI) nel settembre 1943, ma fu senz’altro il più vasto e, così mette in luce la storiografia, il primo a non limitarsi a semplici rivendicazioni economiche.
L’1 marzo 1944 migliaia di operai in tutto il Nord Italia scesero in sciopero spinti soprattutto dalle precettazioni obbligatorie in Germania. Non fu il primo sciopero verificatosi dalla nascita della Repubblica Sociale Italiana (RSI) nel settembre 1943, ma fu senz’altro il più vasto e, così mette in luce la storiografia, il primo a non limitarsi a semplici rivendicazioni economiche.
A Schio quello sciopero pare cominciasse addirittura con qualche anticipo rispetto al resto del territorio: lo ha sostenuto un paio di anni fa lo storico Ugo De Grandis, che nell’anniversario dei fatti ha rilasciato questa intervista a Alessandro Pagano Dritto per VicenzaPiù.
Marzo 1944. Nel suo scritto lei parla del carattere eccezionale dello sciopero scledense e per descrivere l’atteggiamento tenuto nei suoi riguardi, come nei riguardi, più in generale, della storia della Resistenza di Schio e del Veneto, usa l’espressione «coltre di silenzio» (p. 4). Può spiegare meglio questa sua tesi?
Quella contro l’oblio nel quale la storiografia ufficiale della Resistenza ha confinato la storia di Schio e degli scledensi è una battaglia personale che conduco da anni. L’esempio più lampante di questo atteggiamento è proprio l’interpretazione di questi scioperi. Schio in quel frangente segnò uno dei tanti primati della sua storia: fu la prima comunità a iniziare a scioperare e l’unica in cui gli operai abbiano trattato direttamente coi tedeschi senza poi subire per questo motivo ritorsioni. Io fisso la data del 29 febbraio – il 1944 era un anno bisestile – come inizio dello sciopero generale collettivo di tutti gli stabilimenti scledensi, ma in realtà le prime astensioni dal lavoro erano iniziate lunedì 28: in quella data si era infatti sparsa in città la voce che alcuni lavoratori avessero ricevuto le cartoline precetto per recarsi alla visita ed essere giudicati idonei o meno al lavoro coatto in Germania. Ma lo sciopero era stato addirittura programmato, a livello più ampio, per il 21 febbraio e in un primo momento doveva coinvolgere solo il triangolo industriale formato da Lombardia, Piemonte e Liguria. Veneto ed Emilia Romagna erano state volutamente escluse dal cosiddetto Comitato di Agitazione perché considerate regioni periferiche: la loro massa, prevalentemente impiegata nell’agricoltura, era considerata priva di preparazione politica e non sufficientemente preparata a forme organizzate di protesta.
Perché l’eccezionalità dimostrata in questo frangente non è riuscita a dare giusta luce alla Resistenza veneta? Da dove pensa che derivi questa tendenza?
Secondo me è perché la memoria della Resistenza, è inutile negarlo, è da sempre stata portata avanti dai partiti di sinistra e dagli intellettuali di sinistra. Il Veneto non ha mai dato grandi espressioni di intellettualità di sinistra e lo stesso vale anche dal punto di vista delle memorie della Resistenza. Noi non possiamo vantare un Beppe Fenoglio, un Cesare Pavese, un Davide Lajolo; abbiamo, è vero, Luigi Meneghello, che però sulla Resistenza ha scritto solo di passaggio, abbiamo Mario Rigoni Stern che però ha parlato della guerra, dell’internamento militare, ma non di Resistenza. A noi in generale tutto questo manca e quindi quando in Italia si parla di Resistenza armata, si parla della Valdossola, delle Langhe, si parla di Sesto San Giovanni se si parla di Resistenza operaia, del Lingotto o di Sanpierdarena, ma mai e poi mai del Veneto: le stesse dirigenze del Partito Comunista hanno sempre guardato con sufficienza questa terra. Delle zone libere tutti ricordano, per esempio, la Valdossola, che aveva alle spalle la Svizzera neutrale; nessuno invece ricorda Posina, che certi hanno considerato un errore perché ha provocato un immane rastrellamento ma che rispondeva comunque a direttive nazionali. Eppure questa, Posina, aveva alle spalle i territori del Terzo Reich, non la Svizzera.
I mesi che precedettero lo sciopero. Nel suo libro assume una certa rilevanza, per questo preciso periodo, una figura della dirigenza comunista veneta: Giuseppe Banchieri «Anselmo». Chi era?
Banchieri era Segretario federale regionale, il numero uno nel Veneto. Venne a Schio ai primi di gennaio per indagare sui fatti di Malga Silvagno, dove erano stati uccisi quattro partigiani garibaldini. Indagando individuò delle lacune nell’organizzazione, lacune che mi sento però di giustificare. Schio era infatti stata fortemente penalizzata nei primi tentativi di imbastire una resistenza, con il rastrellamento del Festaro di metà ottobre e poi con l’arresto di almeno due importanti elementi a novembre: Nello Pegoraro e Pietro Bressan, trasferiti, come altri prima, a Verona. A questo si aggiungeva il fatto che qualcuno si ostinava ancora a rimanere nelle Commissioni interne che nelle fabbriche si erano create dopo il 25 luglio nel clima della ritrovata «democrazia», con tanto di virgolette, dei quarantacinque giorni di Badoglio. Queste Commissioni erano poi divenute uno strumento di controllo del regime e dovevano quindi essere disertate dai lavoratori. Banchieri passò a setaccio l’organizzazione ed effettuò alcune sostituzioni importanti. Tra queste, quella di Domenico Marchioro, che, dopo Pietro Tresso, era stata la figura numero due del comunismo locale: onorevole del PCd’I, era stato arrestato nel 1926 con tutta la dirigenza comunista dell’epoca, con Gramsci e Scoccimarro, e processato. Rientrato dopo quasi diciotto anni di carcere, Marchioro si vide affidare per riconoscenza la gestione della segreteria provinciale, ma si dimostrò ben poco affidabile: era rimasto con la mentalità semilegale della prima metà degli anni ’20 e non capiva le necessità della condizione clandestina del momento. Fu quindi trasferito a Roma con la scusa della salvaguardia personale.
Ed è a questo punto che entra in gioco un’altra importante figura, quella di Antonio Bietolini «Lorenzo».
Esatto, nel posto che fu di Domenico Marchioro fu inserito Antonio Bietolini. Se devo dire la verità, Bietolini mi ha sempre dato l’impressione del funzionario che sentenzia dall’alto senza calarsi nella realtà locale di altri quadri politici; di quei quadri cioè che lavorano in fabbrica, che sono esposti agli occhi di tutti e che devono gestire la loro attività in una situazione diversa dalla clandestinità dell’elemento di partito venuto da fuori sotto falso nome. Non era l’unico: lo stesso Giorgio Amendola si comportò così, dando un giudizio sprezzante dell’organizzazione delle brigate Garibaldi in tutto il Veneto, osservato però dalla sola Padova. Ma ciò che di Bietolini mi ha infastidito di più è stata una certa arroganza a volersi attribuire l’organizzazione dello sciopero, cosa che non considero vera almeno in relazione a Schio. A Vicenza infatti dovette insistere perché Vicenza non era una realtà industriale pari a Schio, dovette insistere anche a Valdagno, realtà industriale, sì, ma più isolata, meno incline ad avventure rispetto a Schio; a Schio però trovò le cose già fatte. Eppure lui rivendicò il merito dichiarando che nel più grande stabilimento scledense, il lanificio Rossi, aveva trovato solo cinque operai comunisti e neppure organizzati in cellula. Non mi sembra proprio possibile.
Perché le affermazioni di Bietolini sul numero di operai comunisti al Rossi non le sembrano plausibili?
Dal 1873 fino al 1921 Schio aveva espresso una lunga tradizione di scioperi, forti a tal punto da paralizzare la città per settimane, nel 1921 addirittura per mesi dall’estate fino a metà autunno: tutte le fabbriche furono paralizzate. Mi riesce difficile credere allora che nel 1944 al Rossi ci fossero solo cinque comunisti. I documenti dell’Archivio Centrale dello Stato mostrano che a metà degli anni ’30 a Schio c’erano 188 schedati come sovversivi: comunisti, anarchici e socialisti. Unendo a Schio i paesi del circondario – quindi Marano Vicentino, Santorso, Torre Belvicino e San Vito di Leguzzano – si arriva a 329. In occasione di una retata del novembre del 1937, un’indagine dell’OVRA portò alla denuncia di una cinquantina di attivisti che finirono in carcere al confino per sei anni, ma ciò nonostante l’attività sovversiva continuò. No, non credo alla cifra riportata da Bietolini, che nelle sue relazioni sembra il dirigente di partito che viene e bacchetta gli scolaretti. Non fu così e lo dimostra il fatto che in tutti i suoi andirivieni tra Vicenza, Schio e i paesi vicini, quando arrivò a Schio lo sciopero era già stato anticipato perché si era diffusa la notizia delle cartoline precetto: la scritta domani nei volantini già stampati dovette essere corretta a penna con la scritta oggi. No, nell’organizzazione dello sciopero furono direttamente coinvolti i comunisti scledensi: Antonio Canova, Arturo Rigoni, Giuseppe Scala, Livio Cracco, Pierfranco Pozzer, Igino Manea, Giambattista Cavaliere. Tutti nomi che poi hanno proseguito nella resistenza civile: Canova diventò per esempio comandante del battaglione territoriale «Fratelli Bandiera».
Come si svolse lo sciopero in paese e come reagì la controparte?
Le fabbriche furono subito circondate da truppe di SS provenienti da Vicenza. Ci fu un primo tentativo di mediazione del Commissario Prefettizio Giulio Vescovi, tentativo che però fu giudicato dallo stesso Capo dell’Ufficio Annonario del Comune di Schio, il cattolico Igino Rampon, con l’aggettivo «evanescente». Fu allora deciso di inviare una delegazione di operai di Schio, circa una quindicina, nella sede dei sindacati fascisti a Vicenza. Bisogna capire che questo fu uno sciopero politico, diversamente da quelli precedenti cui avevano partecipato anche quei fascisti non contenti dell’entrata in guerra. Qui non si trattava, come prima, di migliorie del vitto: non si voleva andare in Germania. Era uno sciopero contro la Repubblica Sociale, contro l’occupazione tedesca, contro la guerra e la risposta del popolo lavoratore alla socializzazione.
A Vicenza poi i delegati trattarono direttamente con un ufficiale tedesco di elevato grado venuto, sembra, da Brescia, che accettò di ritirare le precettazioni a patto che il lavoro ricominciasse subito. A differenza che altrove non vi furono rappresaglie naziste per questo sciopero e questa è un’altra eccezionalità.
Leggendo i rapporti che lei trascrive nel suo libro, si ha la sensazione che Bietolini non avesse gradito troppo la soluzione della Commissione mandata a Vicenza. Per i comunisti scledensi la Commissione poté dirsi un successo?
Io la vedo come un successo. Torno a dire: il dirigente che viene da Roma e giudica le cose dall’alto avrebbe voluto magari lo scontro all’ultimo sangue, nessuna trattazione e lo sciopero a oltranza. Con il rischio, poi, delle deportazioni? Questi erano i paraocchi del dirigente, del rivoluzionario avulso dalla realtà quotidiana. Gli operai scledensi non potevano spingere oltre, sono convinto che passarono veramente, e comunque, due brutte giornate: avevano persino preparato le vie di fuga nel caso di arresti o attacchi. Non dimentichiamo che ad Arzignano in quel periodo uno sciopero costò la vita a quattro operai, fucilati. Credo che in questo, nel non voler cioè arrivare allo scontro finale, abbia giocato un grande ruolo l’importanza strategica di Schio e delle sue industrie per l’economia di guerra tedesca: si parla di un patrimonio industriale valutato all’epoca circa 80 miliardi di lire.
Bietolini parla di un solo comunista all’interno della Commissione, entrato giusto per permettere sulla stessa una qualche influenza. Quanto contarono effettivamente i comunisti al suo interno?
Difficile dirlo, bisognerebbe conoscere i nomi di tutti i componenti. Secondo me evitarono di farne parte gli antifascisti più in vista, quelli più ricercati e rientrati dal confino. I nomi che si conoscono – Giuseppe Sandonà, Domenico Rigoni, Vittorio Negrizzolo per esempio – non erano nomi di antifascisti schedati, potevano presentarsi e trattare per conto degli operai. Non potevano certo altrettanto un Alessandro Cogollo o un Livio Cracco appena rientrati da sei anni di carcere: e sono cose come queste che Bietolini dimostrava di non capire.
Emilio Trivellato, lo storico che prima di lei scrisse alcune pagine sugli eventi, ricorda un incontro tra Giuseppe Sandonà, che gli rende anni dopo la testimonianza, e proprio Alessandro Cogollo: i due si incontrano alla trattoria La Pergola, noto ritrovo dell’antifascismo scledense. Sostiene Sandonà che le preoccupazioni per l’evolversi della situazione erano visibili da entrambe le parti, quella tedesca e quella antifascista. Che idea si è fatto del clima che si poteva respirare in quei momenti?
Doveva essere brutto, pessimo. Bisogna sempre ricordare che il primo sciopero dichiaratamente politico a Schio era avvenuto il 10 settembre 1943, quando erano stati portati via i militari della Caserma «Cella». L’attacco avvenne di notte, ma quando al mattino giunse la colonna di autocorriere e a Schio si sparse la voce che i tedeschi avevano occupato la città aprendo il fuoco e uccidendo quattro persone, deportando gli altri, le fabbriche scesero in sciopero, i negozi chiusero e la gente in strada tentava di bloccare le autocorriere. Quindi c’era l’intuizione che a mettersi contro i tedeschi si rischiava di essere caricati su una corriera per un viaggio verso il vuoto. Non è poi vero che nel 1944 nessuno sapesse cosa succedeva in Germania. Certo, camere a gas e forni crematori non li aveva visti nessuno, però prima dell’8 settembre ci fu qualche fortunato che, espatriato da volontario, riuscì poi a rimpatriare con qualche stratagemma e che una volta tornato raccontò come venivano tenuti non solo gli operai specializzati italiani, ma soprattutto i civili russi. Oltretutto dal 25 luglio erano state bloccate le rimesse e qua a Schio non era più arrivato nemmeno un centesimo dai lavoratori volontari divenuti, dopo il colpo di Stato di Badoglio, schiavi. Sapendo tutto questo, come potevano gli operai accettare la cartolina di precetto coatto? Ma nemmeno portare la sfida all’estremo conveniva. Dal punto di vista tedesco, invece, bisogna tenere conto che tutte queste industrie erano state requisite proprio da loro, dai tedeschi: deportando gli operai, chi ci avrebbe lavorato? I tedeschi finirono infatti col comprendere che conveniva cambiare tattica: portare le commesse qua, in fabbriche funzionanti e attive al loro servizio, piuttosto che deportare gli operai in Germania. Anche perché le minacce di arrivo di cartoline spingevano gli operai a lasciare le fabbriche e andare in montagna.
Nei rapporti di Bietolini si percepisce una certa attenzione al problema della stampa e della mancanza di informazione, che secondo il dirigente comunista isolò l’ambiente scledense e rese l’esito dello sciopero diverso da quello da lui sperato. Che influssi ebbe, secondo lei, questo aspetto nella vicenda?
Non è che a Schio girasse all’epoca chissà quale stampa, al massimo qualche copia clandestina dell’Unità passava di nascosto tra i telai. Ma le maggiori informazioni arrivavano dalle radio, per esempio Radio Londra. Durante lo sciopero si erano fatti saltare i tralicci del telefono per impedire le comunicazioni dei tedeschi, ma così anche gli operai erano rimasti isolati. I collegamenti migliorarono semmai dopo, nei mesi successivi, con l’evolversi della situazione delle formazioni partigiane in montagna e i collegamenti via radio degli Alleati, ma all’epoca degli scioperi si era ancora agli inizi e le radio erano state tutte requisite. Non è un caso che si fosse puntato molto su questo isolamento per tentare di far fallire lo sciopero. In generale comunque continuo a pensare che le valutazioni di Bietolini debbano essere lette tenendo presente questo carattere del dirigente che non giudica dal basso.
Di solito, quando si parla di Resistenza, si ha sempre in mente la figura del ribelle armato che combatte in montagna; sotto tono sembra passare invece la resistenza civile espressa per esempio dagli scioperi. Come mai, secondo lei?
La figura del guerrigliero che vive in montagna e fa uso delle armi, che si scontra e partecipa a sabotaggi e azioni di fuoco, è senza dubbio più epica. Ma io ricordo anche i racconti di mia nonna, operaia al lanificio Rossi, che mi diceva di come tra di loro operai raccogliessero soldi, imboscassero garze, lana per fare un paio di calzettoni da mandare a un partigiano che nemmeno sapevano chi fosse. E questo è anche il motivo per cui la figura della donna è sempre rimasta in secondo piano: perché ha compiuto migliaia di azioni rischiose ma non lo scontro a fuoco, il sabotaggio del ponte o il disarmo della guarnigione. Per ciò che non è lotta armata o si ha la fortuna di avere un memoriale di qualcuno che ha partecipato alla Resistenza civile o altrimenti si rischia di perderne la memoria. Azioni come fare una calza di lana la sera dopo il lavoro possono sembrare banali, ma è anche grazie a queste che i partigiani in montagna sono sopravvissuti.
Ci furono altri scioperi dopo quelli di marzo?
Sì. Nel Quaderno lo cito di sfuggita [pp. 58-59], ma nell’ottobre del 1944 ci fu per esempio un altro sciopero molto importante e ugualmente passato sotto tono, sciopero che fu una risposta alla violenza carnale cui furono oggetto alcune operaie scledensi, precisamente di San Ulderico, da parte di alcuni elementi della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR). Quello sciopero segnò definitivamente l’incapacità del fascismo scledense di gestire l’ordine pubblico, perché un’altra volta dovettero intervenire i tedeschi. Il Commissario Prefettizio, Vescovi, si recò subito al lanificio Cazzola, sceso immediatamente in sciopero perché le operaie in questione lavoravano lì: tentò di mediare chiedendo anche i nomi dei colpevoli, ma la notizia si diffuse in città e tutte le fabbriche scioperarono per tre giorni. Ancora una volta dovette venire qui a Schio un ufficiale tedesco che patteggiò il ritorno al lavoro con l’allontanamento della guarnigione della GNR. Questo fu un ulteriore punto a favore dell’antifascismo civile scledense, che però nella storia nazionale, con tutta la sua città, raramente viene citato. La storiografia di matrice comunista, così come le stesse brigate Garibaldi, hanno sempre marginalizzato il Veneto: considerato «la parrocchia d’Italia», a loro non interessava.
Lei sostiene nel suo Quaderno [p. 2] che lo sciopero si proponeva di ottenere alcuni traguardi, sia a livello locale che nazionale: danneggiare i tedeschi, sottrarre gli operai al fascismo e dimostrare agli Alleati la popolarità dell’antifascismo. Possiamo dire oggi che ci riuscì?
Sì. Lo sciopero del Nord ebbe risonanza mondiale, perché fu la più partecipata e clamorosa manifestazione di protesta a livello europeo. Si aveva l’impressione, allora, che la Liberazione fosse una cosa imminente e bisognava quindi dare un segnale che il popolo italiano era antifascista e antitedesco: cosa che fu recepita e commentata dai comandi alleati e dalle loro radio, perché nessun Paese aveva mai messo in campo una protesta di quelle dimensioni. E questo fu lo scopo principale della dimostrazione.
Il titolo del suo scritto sull’argomento è Gli scioperi del marzo 1944 a Schio (Quaderni di storia e cultura scledense, Libera Associazione Culturale «Livio Cracco», Schio, ottobre 2011, pp. 60, 3 euro).
Intervista a cura di Alessandro Pagano Dritto
(da www.vicenzapiu.com)