 “La causa dell’incidente è stata un errore della crew (equipaggio). Ha manovrato aggressivamente l’aereo, superando la velocità massima di 100 miglia all’ora e scendendo molto più in basso dei 1000 piedi di altezza. Lo schianto non è frutto del caso, perché l’equipaggio ha volato più basso e più veloce di quanto consentito”. Un’ammissione totale di responsabilità quella contenuta nel rapporto investigativo redatto dal generale dei Marines Peter Pace che imputa all’aviazione americana tutta la colpa della tragedia del Cermis, quando, il 3 febbraio 1998, un caccia statunitense trancia il cavo della funivia di Cavalese (Trento) uccidendo venti persone.
“La causa dell’incidente è stata un errore della crew (equipaggio). Ha manovrato aggressivamente l’aereo, superando la velocità massima di 100 miglia all’ora e scendendo molto più in basso dei 1000 piedi di altezza. Lo schianto non è frutto del caso, perché l’equipaggio ha volato più basso e più veloce di quanto consentito”. Un’ammissione totale di responsabilità quella contenuta nel rapporto investigativo redatto dal generale dei Marines Peter Pace che imputa all’aviazione americana tutta la colpa della tragedia del Cermis, quando, il 3 febbraio 1998, un caccia statunitense trancia il cavo della funivia di Cavalese (Trento) uccidendo venti persone.
Il rapporto è stato redatto dalle forze Usa solo un mese dopo l’incidente, ma La Stampa è riuscita ad entrarne in possesso solo oggi. Scrive Pace: “Raccomando che vengano presi i provvedimenti disciplinari e amministrativi appropriati nei confronti dell’equipaggio, e dei comandanti, che non hanno identificato e disseminato le informazioni pertinenti riguardo ai voli di addestramento. Gli Stati Uniti dovranno pagare tutte le richieste di risarcimento per la morte e il danno materiale provocato dall’incidente”.
Insomma, le forze armate americane sono responsabili di quanto accaduto e devono risponderne. Tutta la catena di comando: dai quattro membri dell’equipaggio fino ai comandanti della base militare americana di Aviano, da dove l’aereo si è alzato in volo.
Ma le cose vanno diversamente. Subito dopo il disastro, la magistratura italiana chiede di processare i quattro membri dell’equipaggio, ma, in base alle leggi Nato, ad avere la giurisdizione è la giustizia militare a stelle e strisce. Nonostante l’allora primo ministro Massimo D’Alema abbia chiesto formalmente agli Stati Uniti di rinunciare alla giurisdizione sui quattro membri dell’equipaggio, il processo si celebra in America. All’inizio sono incriminati tutti e quattro i membri della crew, ma il processo procede solo per il pilota Richard Ashby e il navigatore Joseph Schweitzer. Il 4 marzo del 1999 il primo viene assolto, mentre la giuria fa cadere le accuse a carico del secondo ufficiale. Esattamente un anno dopo che il rapporto investigativo redatto dal generale Pace li inchiodava alle loro responsabilità. Ma c’è di più. Sì perché i militari non solo hanno violato i regolamenti per i voli di addestramento uccidendo 19 turisti e un lavoratore, ma hanno anche inquinato le prove. A bordo del velivolo c’era infatti una telecamera con cui l’equipaggio aveva girato un video della missione. Peccato che una volta a terra, il filmato fosse stato cancellato. I due vengono giudicati colpevoli per avere “ostruito la giustizia”, per avere avuto “una condotta impropria per un ufficiale e gentiluomo” e vengono dimessi dalle forze armate. Il pilota viene condannato a sei mesi di carcere (ne sconterà quattro e mezzo per buona condotta), il suo vice non fa neanche un giorno di galera.
E i risarcimenti per i familiari delle vittime? I primi soldi li elargisce il governo italiano nel febbraio 1999, 65mila euro per ogni vittima. Una legge che prevede lo stanziamento di 40 milioni di dollari viene bocciato dal Congresso americano e nel dicembre dello stesso anno il Parlamento italiano eroga 1,9 milioni di dollari. Cifra che, secondo gli accordi dell’Alleanza atlantica, vengono rimborsati al 75 per cento dagli States.
Una storia di impunità che il documento pubblicato dalla Stampa mette nero su bianco: secondo il rapporto infatti, a bordo dell’aereo c’erano i documenti che vietavano i voli a bassa quota e soprattutto c’erano le mappe che segnalavano la presenza della funivia. Ma nessuno aveva aperto quelle buste. Elementi che hanno fatto dire a Pace che l’America doveva pagare per gli errori commessi. Ma la storia dimostra che aveva torto. (da “Il Fatto” del 13 luglio 2011)
Autore: Roberto
Come la Nato ha scavato sotto l’Ucraina (di Manlio Dinucci)

«Ben scavato, vecchia talpa!»: così Marx descriveva il lavoro preparatorio della rivoluzione a metà Ottocento. La stessa immagine può essere usata oggi, in senso rovesciato, per descrivere l’operazione condotta dalla Nato in Ucraina.
Essa inizia quando nel 1991, dopo il Patto di Varsavia, si disgrega anche l’Unione Sovietica: al posto di un unico stato se ne formano quindici, tra cui l’Ucraina. Gli Stati Uniti e gli alleati europei si muovono subito per trarre il massimo vantaggio dalla nuova situazione geopolitica. Nel 1999 la Nato demolisce con la guerra la Federazione Iugoslava, stato che avrebbe potuto ostacolare la sua espansione a Est, e ingloba i primi paesi dell’ex Patto di Varsavia: Polonia, Repubblica ceca e Ungheria. Quindi, nel 2004 e 2009, si estende a Estonia, Lettonia, Lituania (già parte dell’Urss); Bulgaria, Romania, Slovacchia; Slovenia e Croazia (repubbliche della ex Iugoslavia) e Albania.
L’Ucraina – il cui territorio di oltre 600mila km2 fa da cuscinetto tra Nato e Russia ed è attraversato dai corridoi energetici tra Russia e Ue – resta invece autonoma. Entra però a far parte del «Consiglio di cooperazione nord-atlantica» e, nel 1994, della «Partnership per la pace», contribuendo alle operazioni di «peacekeeping» nei Balcani.
Nel 2002 viene adottato il «Piano di azione Nato-Ucraina» e il presidente Kuchma annuncia l’intenzione di aderire alla Nato. Nel 2005, sulla scia della «rivoluzione arancione», il presidente Yushchenko viene invitato al summit Nato a Bruxelles. Subito dopo viene lanciato un «dialogo intensificato sull’aspirazione dell’Ucraina a divenire membro della Nato» e nel 2008 il summit di Bucarest dà luce verde al suo ingresso. Nel 2009 Kiev firma un accordo che permette il transito terrestre in Ucraina di rifornimenti per le forze Nato in Afghanistan. Ormai l’adesione alla Nato sembra certa ma, nel 2010, il neoeletto presidente Yanukovych annuncia che, pur continuando la cooperazione, l’adesione alla Nato non è nell’agenda del suo governo.
Nel frattempo però la Nato è riuscita a tessere una rete di legami all’interno delle forze armate ucraine. Alti ufficiali partecipano da anni a corsi del Nato Defense College a Roma e a Oberammergau (Germania), su temi riguardanti l’integrazione delle forze armate ucraine con quelle Nato. Nello stesso quadro si inserisce l’istituzione, presso l’Accademia militare ucraina, di una nuova «facoltà multinazionale» con docenti Nato. Notevolmente sviluppata anche la cooperazione tecnico-scientifica nel campo degli armamenti per facilitare, attraverso una maggiore interoperabilità, la partecipazione delle forze armate ucraine a «operazioni congiunte per la pace» a guida Nato.
Inoltre, dato che «molti ucraini mancano di informazioni sul ruolo e gli scopi dell’Alleanza e conservano nella propria mente sorpassati stereotipi della guerra fredda», la Nato istituisce a Kiev un Centro di informazione che organizza incontri e seminari e anche visite di «rappresentanti della società civile» al quartier generale di Bruxelles.
E poiché non esiste solo ciò che si vede, è evidente che la Nato ha una rete di collegamenti negli ambienti militari e civili molto più estesa di quella che appare. Lo conferma il tono di comando con cui il segretario generale della Nato si rivolge il 20 febbraio alle forze armate ucraine, avvertendole di «restare neutrali», pena «gravi conseguenze negative per le nostre relazioni». La Nato si sente ormai sicura di poter compiere un altro passo nella sua espansione ad Est, inglobando probabilmente metà Ucraina, mentre continua la sua campagna contro «i sorpassati stereotipi della guerra fredda».
(il manifesto, 25 febbraio 2014)
Riuniti a Bruxelles i ministri della difesa: la nuova strategia di guerra della Nato
Una Pinotti raggiante di gioia, per la sua prima volta alla Nato (il sogno di una vita), ha partecipato alla riunione dei ministri della difesa svoltasi il 26-27 febbraio al quartier generale di Bruxelles.
Primo punto all’ordine del giorno l’Ucraina, con la quale – sottolineano i ministri nella loro dichiarazione – la Nato ha una «distintiva partnership» nel cui quadro continua ad «assisterla per la realizzazione delle riforme». Prioritaria «la cooperazione militare» (grimaldello con cui la Nato è penetrata in Ucraina). I ministri «lodano le forze armate ucraine per non essere intervenute nella crisi politica» (lasciando così mano libera ai gruppi armati) e ribadiscono che per «la sicurezza euro-atlantica» è fondamentale una «Ucraina stabile» (ossia stabilmente sotto la Nato).
I ministri hanno quindi trattato il tema centrale della Connected Forces Initiative, la quale prevede una intensificazione dell’addestramento e delle esercitazioni che, unitamente all’uso di tecnologie militari sempre più avanzate, permetterà alla Nato di mantenere un’alta «prontezza operativa ed efficacia nel combattimento». Per verificare la preparazione, si svolgerà nel 2015 una delle maggiori esercitazioni Nato «dal vivo», con la partecipazione di forze terrestri, marittime e aeree di tutta l’Alleanza. La prima di una serie, che l’Italia si è offerta di ospitare.
Viene allo stesso tempo potenziata la «Forza di risposta della Nato» che, composta da unità terrestri, aeree e marittime fornite e rotazione dagli alleati, è pronta ad essere proiettata in qualsiasi momento in qualsiasi teatro bellico. Nell’addestramento dei suoi 13mila uomini, svolge un ruolo chiave il nuovo quartier generale delle Forze per le operazioni speciali che, situato in Belgio, è comandato dal vice-ammiraglio statunitense Sean Pybus dei Navy Seals.
La preparazione di queste forze rientra nel nuovo concetto strategico adottato dall’Alleanza, sulla scia del riorientamento strategico statunitense. Per spiegarlo meglio è intervenuto a Bruxelles il segretario alla difesa Chuck Hagel, che ha da poco annunciato un ridimensionamento delle forze terrestri Usa da 520mila e circa 450mila militari. Ma, mentre riduce le truppe, il Pentagono accresce le forze speciali da 66mila a 70mila, con uno stanziamento aggiuntivo di 26 miliardi di dollari per l’addestramento. Gli Usa, spiega Hagel, «non intendono più essere coinvolti in grandi e prolungate operazioni di stabilità oltremare, sulla scala di quelle dell’Iraq e l’Afghanistan». È il nuovo modo di fare la guerra, condotta in modo coperto attraverso forze speciali infiltrate, droni armati, gruppi (anche esterni) finanziati e armati per destabilizzare il paese, che preparano il terreno all’attacco condotto da forze aeree e navali. La nuova strategia, messa a punto con la guerra di Libia, implica un maggiore coinvolgimento degli alleati.
In tale quadro il ministro Pinotti ha ricevuto l’onore di avere a Bruxelles un colloquio bilaterale col segretario Hagel che, si legge in un comunicato del Pentagono, «ha ringraziato la Pinotti per la sua leadership e per il forte contributo dell’Italia alla Nato, inclusa la missione Isaf». Hagel ha anche espresso il solenne «impegno di continuare a cercare modi per approfondire la relazione bilaterale con l’Italia». C’è da aspettarsi quindi ancora di più dalla «relazione bilaterale» con gli Usa, oltre agli F-35, al Muos di Niscemi, al potenziamento di Sigonella e delle altre basi Usa sul nostro territorio, all’invio di forze italiane nei vari teatri bellici agli ordini di fatto del Pentagono. Soprattutto ora che ministro della difesa è Roberta Pinotti, la cui «leadeship» ha contribuito a far salire l’Italia al decimo posto tra i paesi con le più alte spese militari del mondo: 70 milioni di euro al giorno, secondo il Sipri, mentre si annunciano nuovi tagli alla spesa pubblica.
(il manifesto, 28 febbraio 2014)
Intervista a Ugo De Grandis sullo sciopero del 29 febbraio1944 a Schio
 L’1 marzo 1944 migliaia di operai in tutto il Nord Italia scesero in sciopero spinti soprattutto dalle precettazioni obbligatorie in Germania. Non fu il primo sciopero verificatosi dalla nascita della Repubblica Sociale Italiana (RSI) nel settembre 1943, ma fu senz’altro il più vasto e, così mette in luce la storiografia, il primo a non limitarsi a semplici rivendicazioni economiche.
L’1 marzo 1944 migliaia di operai in tutto il Nord Italia scesero in sciopero spinti soprattutto dalle precettazioni obbligatorie in Germania. Non fu il primo sciopero verificatosi dalla nascita della Repubblica Sociale Italiana (RSI) nel settembre 1943, ma fu senz’altro il più vasto e, così mette in luce la storiografia, il primo a non limitarsi a semplici rivendicazioni economiche.
A Schio quello sciopero pare cominciasse addirittura con qualche anticipo rispetto al resto del territorio: lo ha sostenuto un paio di anni fa lo storico Ugo De Grandis, che nell’anniversario dei fatti ha rilasciato questa intervista a Alessandro Pagano Dritto per VicenzaPiù.
Marzo 1944. Nel suo scritto lei parla del carattere eccezionale dello sciopero scledense e per descrivere l’atteggiamento tenuto nei suoi riguardi, come nei riguardi, più in generale, della storia della Resistenza di Schio e del Veneto, usa l’espressione «coltre di silenzio» (p. 4). Può spiegare meglio questa sua tesi?
Quella contro l’oblio nel quale la storiografia ufficiale della Resistenza ha confinato la storia di Schio e degli scledensi è una battaglia personale che conduco da anni. L’esempio più lampante di questo atteggiamento è proprio l’interpretazione di questi scioperi. Schio in quel frangente segnò uno dei tanti primati della sua storia: fu la prima comunità a iniziare a scioperare e l’unica in cui gli operai abbiano trattato direttamente coi tedeschi senza poi subire per questo motivo ritorsioni. Io fisso la data del 29 febbraio – il 1944 era un anno bisestile – come inizio dello sciopero generale collettivo di tutti gli stabilimenti scledensi, ma in realtà le prime astensioni dal lavoro erano iniziate lunedì 28: in quella data si era infatti sparsa in città la voce che alcuni lavoratori avessero ricevuto le cartoline precetto per recarsi alla visita ed essere giudicati idonei o meno al lavoro coatto in Germania. Ma lo sciopero era stato addirittura programmato, a livello più ampio, per il 21 febbraio e in un primo momento doveva coinvolgere solo il triangolo industriale formato da Lombardia, Piemonte e Liguria. Veneto ed Emilia Romagna erano state volutamente escluse dal cosiddetto Comitato di Agitazione perché considerate regioni periferiche: la loro massa, prevalentemente impiegata nell’agricoltura, era considerata priva di preparazione politica e non sufficientemente preparata a forme organizzate di protesta.
Perché l’eccezionalità dimostrata in questo frangente non è riuscita a dare giusta luce alla Resistenza veneta? Da dove pensa che derivi questa tendenza?
Secondo me è perché la memoria della Resistenza, è inutile negarlo, è da sempre stata portata avanti dai partiti di sinistra e dagli intellettuali di sinistra. Il Veneto non ha mai dato grandi espressioni di intellettualità di sinistra e lo stesso vale anche dal punto di vista delle memorie della Resistenza. Noi non possiamo vantare un Beppe Fenoglio, un Cesare Pavese, un Davide Lajolo; abbiamo, è vero, Luigi Meneghello, che però sulla Resistenza ha scritto solo di passaggio, abbiamo Mario Rigoni Stern che però ha parlato della guerra, dell’internamento militare, ma non di Resistenza. A noi in generale tutto questo manca e quindi quando in Italia si parla di Resistenza armata, si parla della Valdossola, delle Langhe, si parla di Sesto San Giovanni se si parla di Resistenza operaia, del Lingotto o di Sanpierdarena, ma mai e poi mai del Veneto: le stesse dirigenze del Partito Comunista hanno sempre guardato con sufficienza questa terra. Delle zone libere tutti ricordano, per esempio, la Valdossola, che aveva alle spalle la Svizzera neutrale; nessuno invece ricorda Posina, che certi hanno considerato un errore perché ha provocato un immane rastrellamento ma che rispondeva comunque a direttive nazionali. Eppure questa, Posina, aveva alle spalle i territori del Terzo Reich, non la Svizzera.
I mesi che precedettero lo sciopero. Nel suo libro assume una certa rilevanza, per questo preciso periodo, una figura della dirigenza comunista veneta: Giuseppe Banchieri «Anselmo». Chi era?
Banchieri era Segretario federale regionale, il numero uno nel Veneto. Venne a Schio ai primi di gennaio per indagare sui fatti di Malga Silvagno, dove erano stati uccisi quattro partigiani garibaldini. Indagando individuò delle lacune nell’organizzazione, lacune che mi sento però di giustificare. Schio era infatti stata fortemente penalizzata nei primi tentativi di imbastire una resistenza, con il rastrellamento del Festaro di metà ottobre e poi con l’arresto di almeno due importanti elementi a novembre: Nello Pegoraro e Pietro Bressan, trasferiti, come altri prima, a Verona. A questo si aggiungeva il fatto che qualcuno si ostinava ancora a rimanere nelle Commissioni interne che nelle fabbriche si erano create dopo il 25 luglio nel clima della ritrovata «democrazia», con tanto di virgolette, dei quarantacinque giorni di Badoglio. Queste Commissioni erano poi divenute uno strumento di controllo del regime e dovevano quindi essere disertate dai lavoratori. Banchieri passò a setaccio l’organizzazione ed effettuò alcune sostituzioni importanti. Tra queste, quella di Domenico Marchioro, che, dopo Pietro Tresso, era stata la figura numero due del comunismo locale: onorevole del PCd’I, era stato arrestato nel 1926 con tutta la dirigenza comunista dell’epoca, con Gramsci e Scoccimarro, e processato. Rientrato dopo quasi diciotto anni di carcere, Marchioro si vide affidare per riconoscenza la gestione della segreteria provinciale, ma si dimostrò ben poco affidabile: era rimasto con la mentalità semilegale della prima metà degli anni ’20 e non capiva le necessità della condizione clandestina del momento. Fu quindi trasferito a Roma con la scusa della salvaguardia personale.
Ed è a questo punto che entra in gioco un’altra importante figura, quella di Antonio Bietolini «Lorenzo».
Esatto, nel posto che fu di Domenico Marchioro fu inserito Antonio Bietolini. Se devo dire la verità, Bietolini mi ha sempre dato l’impressione del funzionario che sentenzia dall’alto senza calarsi nella realtà locale di altri quadri politici; di quei quadri cioè che lavorano in fabbrica, che sono esposti agli occhi di tutti e che devono gestire la loro attività in una situazione diversa dalla clandestinità dell’elemento di partito venuto da fuori sotto falso nome. Non era l’unico: lo stesso Giorgio Amendola si comportò così, dando un giudizio sprezzante dell’organizzazione delle brigate Garibaldi in tutto il Veneto, osservato però dalla sola Padova. Ma ciò che di Bietolini mi ha infastidito di più è stata una certa arroganza a volersi attribuire l’organizzazione dello sciopero, cosa che non considero vera almeno in relazione a Schio. A Vicenza infatti dovette insistere perché Vicenza non era una realtà industriale pari a Schio, dovette insistere anche a Valdagno, realtà industriale, sì, ma più isolata, meno incline ad avventure rispetto a Schio; a Schio però trovò le cose già fatte. Eppure lui rivendicò il merito dichiarando che nel più grande stabilimento scledense, il lanificio Rossi, aveva trovato solo cinque operai comunisti e neppure organizzati in cellula. Non mi sembra proprio possibile.
Perché le affermazioni di Bietolini sul numero di operai comunisti al Rossi non le sembrano plausibili?
Dal 1873 fino al 1921 Schio aveva espresso una lunga tradizione di scioperi, forti a tal punto da paralizzare la città per settimane, nel 1921 addirittura per mesi dall’estate fino a metà autunno: tutte le fabbriche furono paralizzate. Mi riesce difficile credere allora che nel 1944 al Rossi ci fossero solo cinque comunisti. I documenti dell’Archivio Centrale dello Stato mostrano che a metà degli anni ’30 a Schio c’erano 188 schedati come sovversivi: comunisti, anarchici e socialisti. Unendo a Schio i paesi del circondario – quindi Marano Vicentino, Santorso, Torre Belvicino e San Vito di Leguzzano – si arriva a 329. In occasione di una retata del novembre del 1937, un’indagine dell’OVRA portò alla denuncia di una cinquantina di attivisti che finirono in carcere al confino per sei anni, ma ciò nonostante l’attività sovversiva continuò. No, non credo alla cifra riportata da Bietolini, che nelle sue relazioni sembra il dirigente di partito che viene e bacchetta gli scolaretti. Non fu così e lo dimostra il fatto che in tutti i suoi andirivieni tra Vicenza, Schio e i paesi vicini, quando arrivò a Schio lo sciopero era già stato anticipato perché si era diffusa la notizia delle cartoline precetto: la scritta domani nei volantini già stampati dovette essere corretta a penna con la scritta oggi. No, nell’organizzazione dello sciopero furono direttamente coinvolti i comunisti scledensi: Antonio Canova, Arturo Rigoni, Giuseppe Scala, Livio Cracco, Pierfranco Pozzer, Igino Manea, Giambattista Cavaliere. Tutti nomi che poi hanno proseguito nella resistenza civile: Canova diventò per esempio comandante del battaglione territoriale «Fratelli Bandiera».
Come si svolse lo sciopero in paese e come reagì la controparte?
Le fabbriche furono subito circondate da truppe di SS provenienti da Vicenza. Ci fu un primo tentativo di mediazione del Commissario Prefettizio Giulio Vescovi, tentativo che però fu giudicato dallo stesso Capo dell’Ufficio Annonario del Comune di Schio, il cattolico Igino Rampon, con l’aggettivo «evanescente». Fu allora deciso di inviare una delegazione di operai di Schio, circa una quindicina, nella sede dei sindacati fascisti a Vicenza. Bisogna capire che questo fu uno sciopero politico, diversamente da quelli precedenti cui avevano partecipato anche quei fascisti non contenti dell’entrata in guerra. Qui non si trattava, come prima, di migliorie del vitto: non si voleva andare in Germania. Era uno sciopero contro la Repubblica Sociale, contro l’occupazione tedesca, contro la guerra e la risposta del popolo lavoratore alla socializzazione.
A Vicenza poi i delegati trattarono direttamente con un ufficiale tedesco di elevato grado venuto, sembra, da Brescia, che accettò di ritirare le precettazioni a patto che il lavoro ricominciasse subito. A differenza che altrove non vi furono rappresaglie naziste per questo sciopero e questa è un’altra eccezionalità.
Leggendo i rapporti che lei trascrive nel suo libro, si ha la sensazione che Bietolini non avesse gradito troppo la soluzione della Commissione mandata a Vicenza. Per i comunisti scledensi la Commissione poté dirsi un successo?
Io la vedo come un successo. Torno a dire: il dirigente che viene da Roma e giudica le cose dall’alto avrebbe voluto magari lo scontro all’ultimo sangue, nessuna trattazione e lo sciopero a oltranza. Con il rischio, poi, delle deportazioni? Questi erano i paraocchi del dirigente, del rivoluzionario avulso dalla realtà quotidiana. Gli operai scledensi non potevano spingere oltre, sono convinto che passarono veramente, e comunque, due brutte giornate: avevano persino preparato le vie di fuga nel caso di arresti o attacchi. Non dimentichiamo che ad Arzignano in quel periodo uno sciopero costò la vita a quattro operai, fucilati. Credo che in questo, nel non voler cioè arrivare allo scontro finale, abbia giocato un grande ruolo l’importanza strategica di Schio e delle sue industrie per l’economia di guerra tedesca: si parla di un patrimonio industriale valutato all’epoca circa 80 miliardi di lire.
Bietolini parla di un solo comunista all’interno della Commissione, entrato giusto per permettere sulla stessa una qualche influenza. Quanto contarono effettivamente i comunisti al suo interno?
Difficile dirlo, bisognerebbe conoscere i nomi di tutti i componenti. Secondo me evitarono di farne parte gli antifascisti più in vista, quelli più ricercati e rientrati dal confino. I nomi che si conoscono – Giuseppe Sandonà, Domenico Rigoni, Vittorio Negrizzolo per esempio – non erano nomi di antifascisti schedati, potevano presentarsi e trattare per conto degli operai. Non potevano certo altrettanto un Alessandro Cogollo o un Livio Cracco appena rientrati da sei anni di carcere: e sono cose come queste che Bietolini dimostrava di non capire.
Emilio Trivellato, lo storico che prima di lei scrisse alcune pagine sugli eventi, ricorda un incontro tra Giuseppe Sandonà, che gli rende anni dopo la testimonianza, e proprio Alessandro Cogollo: i due si incontrano alla trattoria La Pergola, noto ritrovo dell’antifascismo scledense. Sostiene Sandonà che le preoccupazioni per l’evolversi della situazione erano visibili da entrambe le parti, quella tedesca e quella antifascista. Che idea si è fatto del clima che si poteva respirare in quei momenti?
Doveva essere brutto, pessimo. Bisogna sempre ricordare che il primo sciopero dichiaratamente politico a Schio era avvenuto il 10 settembre 1943, quando erano stati portati via i militari della Caserma «Cella». L’attacco avvenne di notte, ma quando al mattino giunse la colonna di autocorriere e a Schio si sparse la voce che i tedeschi avevano occupato la città aprendo il fuoco e uccidendo quattro persone, deportando gli altri, le fabbriche scesero in sciopero, i negozi chiusero e la gente in strada tentava di bloccare le autocorriere. Quindi c’era l’intuizione che a mettersi contro i tedeschi si rischiava di essere caricati su una corriera per un viaggio verso il vuoto. Non è poi vero che nel 1944 nessuno sapesse cosa succedeva in Germania. Certo, camere a gas e forni crematori non li aveva visti nessuno, però prima dell’8 settembre ci fu qualche fortunato che, espatriato da volontario, riuscì poi a rimpatriare con qualche stratagemma e che una volta tornato raccontò come venivano tenuti non solo gli operai specializzati italiani, ma soprattutto i civili russi. Oltretutto dal 25 luglio erano state bloccate le rimesse e qua a Schio non era più arrivato nemmeno un centesimo dai lavoratori volontari divenuti, dopo il colpo di Stato di Badoglio, schiavi. Sapendo tutto questo, come potevano gli operai accettare la cartolina di precetto coatto? Ma nemmeno portare la sfida all’estremo conveniva. Dal punto di vista tedesco, invece, bisogna tenere conto che tutte queste industrie erano state requisite proprio da loro, dai tedeschi: deportando gli operai, chi ci avrebbe lavorato? I tedeschi finirono infatti col comprendere che conveniva cambiare tattica: portare le commesse qua, in fabbriche funzionanti e attive al loro servizio, piuttosto che deportare gli operai in Germania. Anche perché le minacce di arrivo di cartoline spingevano gli operai a lasciare le fabbriche e andare in montagna.
Nei rapporti di Bietolini si percepisce una certa attenzione al problema della stampa e della mancanza di informazione, che secondo il dirigente comunista isolò l’ambiente scledense e rese l’esito dello sciopero diverso da quello da lui sperato. Che influssi ebbe, secondo lei, questo aspetto nella vicenda?
Non è che a Schio girasse all’epoca chissà quale stampa, al massimo qualche copia clandestina dell’Unità passava di nascosto tra i telai. Ma le maggiori informazioni arrivavano dalle radio, per esempio Radio Londra. Durante lo sciopero si erano fatti saltare i tralicci del telefono per impedire le comunicazioni dei tedeschi, ma così anche gli operai erano rimasti isolati. I collegamenti migliorarono semmai dopo, nei mesi successivi, con l’evolversi della situazione delle formazioni partigiane in montagna e i collegamenti via radio degli Alleati, ma all’epoca degli scioperi si era ancora agli inizi e le radio erano state tutte requisite. Non è un caso che si fosse puntato molto su questo isolamento per tentare di far fallire lo sciopero. In generale comunque continuo a pensare che le valutazioni di Bietolini debbano essere lette tenendo presente questo carattere del dirigente che non giudica dal basso.
Di solito, quando si parla di Resistenza, si ha sempre in mente la figura del ribelle armato che combatte in montagna; sotto tono sembra passare invece la resistenza civile espressa per esempio dagli scioperi. Come mai, secondo lei?
La figura del guerrigliero che vive in montagna e fa uso delle armi, che si scontra e partecipa a sabotaggi e azioni di fuoco, è senza dubbio più epica. Ma io ricordo anche i racconti di mia nonna, operaia al lanificio Rossi, che mi diceva di come tra di loro operai raccogliessero soldi, imboscassero garze, lana per fare un paio di calzettoni da mandare a un partigiano che nemmeno sapevano chi fosse. E questo è anche il motivo per cui la figura della donna è sempre rimasta in secondo piano: perché ha compiuto migliaia di azioni rischiose ma non lo scontro a fuoco, il sabotaggio del ponte o il disarmo della guarnigione. Per ciò che non è lotta armata o si ha la fortuna di avere un memoriale di qualcuno che ha partecipato alla Resistenza civile o altrimenti si rischia di perderne la memoria. Azioni come fare una calza di lana la sera dopo il lavoro possono sembrare banali, ma è anche grazie a queste che i partigiani in montagna sono sopravvissuti.
Ci furono altri scioperi dopo quelli di marzo?
Sì. Nel Quaderno lo cito di sfuggita [pp. 58-59], ma nell’ottobre del 1944 ci fu per esempio un altro sciopero molto importante e ugualmente passato sotto tono, sciopero che fu una risposta alla violenza carnale cui furono oggetto alcune operaie scledensi, precisamente di San Ulderico, da parte di alcuni elementi della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR). Quello sciopero segnò definitivamente l’incapacità del fascismo scledense di gestire l’ordine pubblico, perché un’altra volta dovettero intervenire i tedeschi. Il Commissario Prefettizio, Vescovi, si recò subito al lanificio Cazzola, sceso immediatamente in sciopero perché le operaie in questione lavoravano lì: tentò di mediare chiedendo anche i nomi dei colpevoli, ma la notizia si diffuse in città e tutte le fabbriche scioperarono per tre giorni. Ancora una volta dovette venire qui a Schio un ufficiale tedesco che patteggiò il ritorno al lavoro con l’allontanamento della guarnigione della GNR. Questo fu un ulteriore punto a favore dell’antifascismo civile scledense, che però nella storia nazionale, con tutta la sua città, raramente viene citato. La storiografia di matrice comunista, così come le stesse brigate Garibaldi, hanno sempre marginalizzato il Veneto: considerato «la parrocchia d’Italia», a loro non interessava.
Lei sostiene nel suo Quaderno [p. 2] che lo sciopero si proponeva di ottenere alcuni traguardi, sia a livello locale che nazionale: danneggiare i tedeschi, sottrarre gli operai al fascismo e dimostrare agli Alleati la popolarità dell’antifascismo. Possiamo dire oggi che ci riuscì?
Sì. Lo sciopero del Nord ebbe risonanza mondiale, perché fu la più partecipata e clamorosa manifestazione di protesta a livello europeo. Si aveva l’impressione, allora, che la Liberazione fosse una cosa imminente e bisognava quindi dare un segnale che il popolo italiano era antifascista e antitedesco: cosa che fu recepita e commentata dai comandi alleati e dalle loro radio, perché nessun Paese aveva mai messo in campo una protesta di quelle dimensioni. E questo fu lo scopo principale della dimostrazione.
Il titolo del suo scritto sull’argomento è Gli scioperi del marzo 1944 a Schio (Quaderni di storia e cultura scledense, Libera Associazione Culturale «Livio Cracco», Schio, ottobre 2011, pp. 60, 3 euro).
Intervista a cura di Alessandro Pagano Dritto
(da www.vicenzapiu.com)
1 marzo 1944: ondata di scioperi in Italia
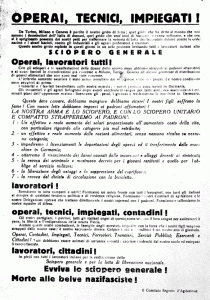 Lo sciopero generale attuato nel Nord Italia dall’1 all’8 marzo 1944 costituì l’atto conclusivo di una serie di agitazioni cominciate, in forme e modalità diverse, già nel settembre 1943, all’indomani della costituzione della Repubblica Sociale Italiana e dell’occupazione tedesca, e sviluppatesi soprattutto nei mesi di novembre e dicembre.
Lo sciopero generale attuato nel Nord Italia dall’1 all’8 marzo 1944 costituì l’atto conclusivo di una serie di agitazioni cominciate, in forme e modalità diverse, già nel settembre 1943, all’indomani della costituzione della Repubblica Sociale Italiana e dell’occupazione tedesca, e sviluppatesi soprattutto nei mesi di novembre e dicembre.
Lo sciopero del marzo 1944 presentò tuttavia una sostanziale novità. Esso fu infatti caratterizzato da una precisa matrice di natura politica, mentre le precedenti agitazioni, seppur non prive di risvolti politici, erano state attuate sostanzialmente in un’ottica di tipo economico-rivendicativo e avevano avuto come scopo primario il miglioramento sia delle condizioni salariali, attraverso la richiesta di aumenti, sia della situazione alimentare.
Con lo sciopero generale del marzo 1944 invece “le lotte operaie assunsero un carattere differente” perché si configurarono come una precisa forma di lotta politica antifascista e antitedesca. Deciso su iniziativa dei comunisti e approvato, dopo qualche esitazione dei socialisti, anche dagli altri partiti che facevano parte del Comitato Nazionale di Liberazione, lo sciopero iniziò il 1° marzo nelle fabbriche del “triangolo industriale”, si diffuse rapidamente e per più di una settimana, fino a quando non venne represso dai tedeschi e dalla polizia di Salò attraverso una massiccia azione di rappresaglia e di deportazione dei lavoratori, bloccò gran parte delle attività produttive del Nord Italia.
Secondo fonti repubblichine allo sciopero parteciparono complessivamente 208.549 operai. A Milano gli scioperanti erano stati 119.000 nell’arco di cinque giorni e a Torino 32.600 per tre giorni. Addirittura maggiore risultava per i tedeschi il numero di coloro che si erano astenuti dal lavoro. Poiché Hitler aveva ordinato di deportare in Germania il 20% degli scioperanti, l’ambasciatore tedesco presso la Repubblica Sociale, Rudolph Rahn, calcolò che tale percentuale corrispondeva a 70.000 persone.
Ciò significava valutare gli astenuti dal lavoro in 350.000, cifra veramente imponente. Proprio il consistente numero di coloro che avrebbero dovuto essere deportati, che avrebbe potuto rivelarsi controproducente sul piano politico e avere conseguenze di rilievo sullo sviluppo della Resistenza, indusse poi i tedeschi a ridurre le deportazioni. Anche se «la cifra esatta» dei deportati «non si è potuta avere», non è tuttavia «improbabile che ammontasse a 1200». Occorre inoltre sottolineare che i lavoratori tennero, nella maggior parte dei casi, un atteggiamento fermo di fronte ai tentativi dei dirigenti politici e sindacali repubblichini di indurli a riprendere il lavoro, cedendo alla fine solo per la repressione tedesca.
Preso in considerazione nell’ottica della «dimostrazione politica», lo sciopero generale ebbe “una grandissima importanza”:
Fu la più grande protesta di massa con la quale dovette confrontarsi la potenza occupante: attuata dimostrativamente senza aiuti dall’esterno, senza armi ma con grande energia e sacrifici. E non fu soltanto (assieme a quello dell’anno precedente) il più importante sciopero in Italia dopo vent’anni di dominio fascista, fu anche il più grande sciopero generale compiuto nell’Europa occupata dai nazionalsocialisti.
A ciò si deve aggiungere che «nella sottovalutazione del peso politico dello sciopero generale» non si è tenuto conto “a sufficienza del fatto che esso si svolgeva in un paese sottoposto alle leggi di guerra e dell’occupazione: più di 200.000 operai contemporaneamente in sciopero, dopo un inverno in cui le fabbriche erano state in continua agitazione, tranne che nel mese di febbraio, era un fatto di eccezionale rilievo e significato”.
Lo sciopero ebbe risvolti importanti anche nel favorire lo sviluppo della Resistenza perché, “dopo questa prima prova di forza condotta con armi diseguali”, fece capire che “ormai il tempo degli scioperi era passato”. La “scena dello scontro” quindi “si trasferì sui monti” e apparve chiaro che “soltanto la lotta armata delle bande partigiane contro gli occupanti avrebbe potuto avere successo”. Non va inoltre dimenticato che le agitazioni diedero il colpo mortale alle speranze dei fascisti di Salò di “agganciare”, attraverso la “socializzazione”, i lavoratori.
Torino in sciopero
A Torino lo sciopero scatta il 1° marzo 1944, nonostante il giorno prima Zerbino, il capo fascista della provincia, abbia comunicato la messa in ferie delle fabbriche, giustificando tale provvedimento con la mancanza di acqua e quindi di energia elettrica. Vengono escluse dal provvedimento una serie di fabbriche, tra cui tutto il complesso Fiat, decisivo per le esigenze belliche.
Seguendo l’appello del Comitato d’agitazione, diffuso nella fabbriche con un volantino clandestino, il 1° marzo scioperano in 60.000; alla sera Zerbino ordina la ripresa del lavoro per l’indomani, 2 marzo, minacciando la chiusura degli stabilimenti, con perdita delle retribuzioni, arresti e deportazioni in campo di concentramento, licenziamento in tronco e perdita dell’esonero per i lavoratori che hanno l’obbligo del servizio militare.
Nonostante queste minacce il 2 marzo l’esempio degli operai Fiat viene seguito dalla stragrande maggioranza delle fabbriche in attività (Zenith, Viberti, Ceat, Rasetti) e scioperano in 70.000, mentre in città vengono sabotate diverse linee tranviarie.
Il 3 marzo gli operai della Grandi Motori Fiat vengono attaccati dai militi fascisti all’uscita della fabbrica e numerosi sono i feriti. Intorno a Torino intervengono a sostegno dello sciopero le formazioni partigiane insediate ad ovest della città con l’obiettivo di interrompere i collegamenti tra Torino e le valli di Lanzo, la Val di Susa, la Val Sangone e la zona di Pinerolo.
In Valsesia sono i partigiani garibaldini a decretare lo sciopero, mentre in Val d’Aosta vengono compiuti atti di sabotaggio a sostegno dello sciopero: vengono interrotte le linee elettriche e danneggiati gli impianti in modo che alcuni dei più importanti complessi industriali della regione vengono paralizzati.
Il 3 marzo la Fiat, seguendo una linea tracciata anche da altri industriali dimostratisi, salvo rare eccezioni, solidali con le forze nazifasciste, decreta la serrata degli stabilimenti. Contemporaneamente, i vertici governativi inviano nelle fabbriche presidi armati. La protesta si protrae fino all’8 marzo, quando il Comitato di agitazione decide la ripresa del lavoro.
La lotta, estesasi successivamente in altre regioni del Nord, assume un significato politico: tradurre sul piano della fabbrica la dichiarazione di guerra consegnata dall’antifascismo torinese al regime fascista fin dall’8 settembre 1943. Al termine degli eventi si stringono le maglie della repressione nazifascista attraverso arresti, ritiri degli esoneri militari e deportazioni nei campi di concentramento tedeschi: circa 400 operai, 178 alla sola Fiat, sono prelevati in fabbrica e portati alla stazione di Porta Nuova, destinazione Mauthausen. Pochi di loro riescono a fare ritorno.
In tutto il Piemonte sono oltre 150 mila gli operai che hanno scioperato.
Testo del volantino clandestino diffuso nelle fabbriche torinesi:
SCIOPERO GENERALE CONTRO LA FAME E CONTRO IL TERRORE
Ancora una volta le masse operaie, strette attorno al COMITATO PROVINCIALE DI AGITAZIONE, scenderanno in lotta per difendere il diritto alla vita e alla libertà di tutto il popolo italiano. Le masse operaie ancora una volta passeranno all’attacco contro i nemici di ogni civiltà, contro i barbari nazifascisti. Le masse operaie scenderanno in lotta contro il terrore e la fame, scenderanno cioè in lotta per difendere la vita di tutti.
L’ora è giunta per dimostrare ai nostri nemici spietati come i torinesi, come i piemontesi formino un solo blocco. Non soltanto gli operai, ma tutti i professionisti, tutti gli impiegati, tutti i cittadini debbono scioperare.
Evviva lo sciopero generale di tutto il grande tenace eroico popolo piemontese.
IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
(da http://storiedimenticate.wordpress.com)
Questa sera alle ore 20.45 a Schio all’osteria “Due Mori”, Ugo de Grandis e Beppe traversa faranno conoscere una storia poco conosciuta: il 29 febbraio 1944 Schio fu la prima città d’Italia a incrociare le braccia contro il fascismo e la precettazione per il lavoro coatto in Germania. Uno dei tanti primati della città che la storia ufficiale ignora.
Politica nuova?
 E’ ben difficile parlare di “nuova politica” di fronte al rapidissimo mutamento di situazione che si è verificato nel giro di una settimana, col Governo Letta “indotto” alle dimissioni e il “trionfo” del nuovo Segretario del PD, che si avvia alla conquista di gran carriera del posto di Presidente del Consiglio, sulla base semplicemente delle decisioni adottate dal suo partito.
E’ ben difficile parlare di “nuova politica” di fronte al rapidissimo mutamento di situazione che si è verificato nel giro di una settimana, col Governo Letta “indotto” alle dimissioni e il “trionfo” del nuovo Segretario del PD, che si avvia alla conquista di gran carriera del posto di Presidente del Consiglio, sulla base semplicemente delle decisioni adottate dal suo partito.
Intanto, è difficile compiacersi e considerare “buona politica” l’improvviso mutamento nelle parole e nelle decisioni del futuro premier. Non lo faccio io, ma l’ha fatto lo stesso quotidiano del suo partito, l’elenco delle cose che da più di un mese andava dicendo (solo per esemplificare: mai più governi di larghe intese, mai accesso alla guida di Palazzo Chigi senza un voto popolare, mai prendere il posto di Letta prima del compimento del semestre europeo, mai rinnovare i riti della vecchia politica); ed ora nel giro di pochi giorni, addirittura di poche ore, tutto è stato cancellato e smentito.
Si va al Governo con Alfano, si costringe Letta alle dimissioni, si cambia quasi tutto il Governo (ma Alfano resta, a quanto pare) con un metodo a dir poco discutibile (pur di dimostrare una pretesa discontinuità, si mandano a casa anche Ministri, come quelli dell’Istruzione che avevano ben meritato), non si fa un pur rapido passaggio in Parlamento, mentre si continua ad ignorare il vero e reale programma del nuovo esecutivo. Non c’è male, come rinnovamento della politica. E non c’è male anche sotto il profilo strettamente istituzionale; il cambio avviene sulla base di rapide e scontate consultazioni, al Parlamento spetterà un voto complessivo, di avallo di un lavoro già compiuto. Che ci siano dei precedenti in termini (un governo “eletto” senza un passaggio parlamentare, con un premier non eletto da nessuno, ma solo indicato dal suo partito), ne dubito. Comunque, conterebbero ben poco, visto che si afferma che si vuole rinnovare la politica.
E non ci si venga a dire che il passaggio parlamentare non era utile perché le dimissioni di Letta erano irrevocabili e dunque non c’era la possibilità che cambiasse idea. Serissimi costituzionalisti hanno già dimostrato che non è così, perché il Parlamento deve essere chiamato in causa, non già per prendere atto delle dimissioni oppure decidere di mantenere in vita il vecchio Governo, ma – essenzialmente – perché tutto avvenga alla luce del sole e con un pubblico dibattito dal quale i cittadini apprendano le ragioni per cui il “passaggio” sta avvenendo, con quelle modalità, con un Governo che non ha avuto la sfiducia, con dimissioni non spiegate, se non da una riunione di partito (peraltro assai ambigua, sul punto), con la scelta di un Presidente del Consiglio estraneo al Parlamento, con un programma tutto da conoscere, prima ancora che da verificare.
Questo dibattito non ci sarà, a quanto apprendiamo.
Anche questa, a tutto concedere, non è proprio una novità e questo è davvero singolare quando si parla continuamente di innovazione e cambiamenti nello stesso modo di far politica.
Con questo, non intendo affatto “difendere” il Governo Letta, che ha le sue responsabilità e le sue colpe, sempre denunciate da queste colonne. Del resto, che ci sia stato e che ci sia qualcosa che non funziona, lo si deduce da quello che sta avvenendo in Parlamento, dove si sta profilando un pauroso ingorgo di decreti in scadenza (5 a febbraio e 3 a marzo); e quali decreti! Basti ricordare che c’è il cosiddetto “mille proroghe”, già carico di una montagna di emendamenti; c’è il finanziamento pubblico dei partiti e c’è il famosissimo decreto “salvaRoma”; e, ancora, lo “svuotamento carceri”, il “destinazione Italia”; il decreto che proroga le missioni all’estero, e così via. Una massa di provvedimenti urgenti e in scadenza, che ingolosiscono le opposizioni, che faranno di tutto per ostacolarli. Un calendario come questo rappresenta di per sé un giudizio negativo, prima che sul Parlamento, sul Governo, che non è stato capace di procedere oculatamente e nelle forme ordinarie.
Ma, detto questo, “non si uccidono così i cavalli”; insomma, anche per cambiare di passo (e di esecutivo) ci vorrebbe un po’ più di garbo (e non parlo solo di “educazione”, ormai smarrito da tempo, ma soprattutto di garbo istituzionale).
In mezzo a tutto questo, guardo ancora – con malcelata nostalgia – alla mia “agenda” della settimana scorsa e mi accorgo che al mio elenco di priorità politiche e soprattutto sociali, non viene contrapposto, allo stato, praticamente nulla che sia noto e conoscibile; eppure, parlavo di “pianificazione degli interventi “(addio ai decreti-legge), di provvedimenti urgentissimi per risolvere la gravissima emergenza sociale, della creazione di un piano organico e mirato per reperire le risorse necessarie ad un rilancio delle attività produttive e alla creazione di posti di lavoro “veri”, di riforma della politica, di forte impegno contro la criminalità organizzata e contro la corruzione; e parlavo anche di riforme istituzionali basate sulla conoscenza, sulla riflessione e sul confronto reale attorno ai modelli possibili per realizzare una concreta differenziazione del lavoro delle due Camere.
Un vero libro di sogni: a Roma si sta parlando, al solito, di posti, di nomi, di caselle da occupare e da destinare, ma gli obiettivi restano nel vago: si parla sempre di riforma della legge elettorale; ma se poi la si fa in un modo da molti giudicato pessimo, e se essa finisce in mezzo all’ingorgo dei decreti, anche su questo c’è poco da sperare, soprattutto se si pensa che bisognerebbe ancora approfondire, confrontarsi, riflettere e non improvvisare.
Ma almeno, a prescindere dalla velocità (anzi, dalla fretta) che è realmente e fin troppo innovativa, qualche “novità” c’è? Certo, ce n’é almeno una, a cui non pensavamo più: la soglia del Quirinale, una volta preclusa a chi aveva anche solo un avviso di garanzia, è stata varcata, a quanto pare, da un condannato, provvisoriamente e incredibilmente libero di circolare, solo perché un Tribunale di sorveglianza sta tardando a decidere se assegnarlo agli arresti domiciliari oppure ai servizi sociali. Questa è davvero un’innovazione, la seconda peraltro, dopo lo “storico” incontro al Nazareno tra due leader entrambi estranei al Parlamento, di cui peraltro uno perché non ha ancora avuto modo di farsi eleggere e l’altro perché dal Senato è stato escluso per decadenza.
Ci sarebbe da sorridere, se non ci fosse da piangere. Ma noi, vecchi combattenti, non sorridiamo e non piangiamo: stringiamo i denti, aspettando che si torni davvero ai valori ed alle regole della Costituzione, che prenda il sopravvento la politica “buona”, che insomma qualcosa cambi davvero, nel nostro Paese. Noi non abbiamo mai disperato ed anche di fronte a prove terribili, continuiamo a pensare e sperare che all’Italia arrida un futuro migliore, all’insegna della nuova politica, dell’antifascismo, della democrazia (parole, quest’ultime, che ci piacerebbe sentire, almeno ogni tanto, nei discorsi e ragionamenti politici, ed invece non si sentono praticamente mai).
Naturalmente, limitarsi a sperare sarebbe troppo poco. Non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo neppure adesso, anche se i tempi sono difficili e complessi. Ma noi – la nostra Associazione – siamo portatori di valori che vengono da lontano e ci parlano di donne e uomini che, per quei valori, hanno lottato e sofferto, non scoraggiandosi mai, ma sempre operando perché essi trionfassero. Se avessimo solo “sperato”, non ci sarebbe stata la Resistenza ed avremmo finito per aspettare l’arrivo degli Alleati. Invece, c’è stato un impegno forte e deciso anche quando tutto sembrava perduto, a fronte di una barbarie incalzante e dotata di uomini e mezzi soverchianti. Quell’impegno ha pagato, alla fine, come pagherà anche oggi se non ci arrenderemo allo sconforto, alla delusione, allo smarrimento e cercheremo di fare sentire, con forza, la voce della Costituzione, la voce, mai incrinata, dei tanti che hanno combattuto per la nostra libertà e per il futuro del Paese.
Carlo Smuraglia – Presidente Nazionale ANPI
Roma, 18/02/2014
Il nuovo dizionario di Matteo: c’è “Paese” e non “Berlusconi”. Spariscono destra e sinistra (di Filippo Ceccarelli da “Repubblica”)
Le parole, al giorno d’oggi, si misurano e si pesano. Ieri Renzi si è rivolto molto più al grande pubblico che ai senatori, che pure ha cercato di coinvolgere, a tratti anche divertendoli, per il resto sforzandosi di stupirli senza troppo preoccuparsi che alcuni si sarebbero disorientati. La novità comunque c’è. Così parlò Renzi in quelle che un tempo si sarebbero definite «dichiarazioni programmatiche» e ieri lui stesso ha suggestivamente assimilato a una specie di «Truman show».
Io, noi. Pronomi interscambiabili. «Apprezzo », «ci avviciniamo», «non vorrei», «abbiamo svolto». Il protagonismo egocentrato convive con una dimensione collettiva, ma nell’economia generale del discorso non è chiaro il motore e la funzione del loro alternarsi. L’effetto suona talvolta come un singolarissimo
plurale majestatis.
Età, la mia età. Segnale di auto-distinzione anagrafica con prezioso richiamo d’esordio al brano della «pur bravissima» Gigliola Cinquetti, che con Renzi, del resto, condivise ai tempi la militanza nei comitati per l’Ulivo. Su un piano storico-oggettivo il tempo presente è indicato come: passaggio. Ma la tentazione della Generazione Erasmus è sempre in agguato.
Derby. Sta per sfida, scontro, conflitto, ma con un aperto pregiudizio di riprovazione. Vedi il «derby ideologico» sulla giustizia. Lessico calcistico, nei due interventi al Senato ridotto tuttavia al minimo.
Coraggio. Un tempo virtù che si riconosceva esclusivamente ai grandi scomparsi, oggi risorsa comunicativa ad alto impatto rivendicata in tempo reale come inconfondibile segno di leadership. Spessa abbinato, ma per negazione e sottrazione, alla paura, «non abbiamo paura», «mai paura», eccetera.
Urgenza. Così come l’accelerazione risuonata nella replica, è la premessa della velocità, dell’impeto e dell’iper-cinetismo del nuovo presidente comunque necessari ad affrontare, anzi a prestissimo risolvere i problemi sul tappeto.
Faccia, facce. Sostantivi eminentemente visivi, quindi televisivi e come tali tipici del renzismo. Il potere sollecita sguardi,trasmette indizi, addita fenomeni che tutti possono guardare, di norma sugli schermi.
Sogno, sogni. Provenienti dalla pubblicità e resi inevitabili nella retorica della Seconda Repubblica dopo l’inaugurazione, l’uso e l’abuso di Berlusconi, ma anche di altri suoi onirici imitatori. Un indubbio progresso, nel caso odierno, la mancanza della consueta citazione di Martin Luther King, «I have a dream».
Fuori. «Fuori di qui», «fuori da quest’aula ». Un modo per sottolineare la propria estraneità alla casta, termine però menzionato ieri appena di sfuggita. «Fuori», senza nemmeno il sottotitolo (Mondadori, 2011), era d’altra parte il titolo di uno dei primi e illuminanti — con il senno di poi — libri di Renzi. Un capitolo dedicato al «complesso di Silvio», l’innominato. E oggi il cognome Berlusconi non è mai risuonato.
La madre di. Fantasioso riciclaggio «giornalese» al linguaggio bellico di Saddam Hussein (1991). «La madre dei nostri problemi», ha detto Renzi, e «la madre di tutte le privatizzazioni». Questa madre non proprio un esempio di premura e bontà.
Papà. «Credo che capire cosa significa incrociare lo sguardo di un papà… « e qui Renzi si è fermato, e ricordandosi di essere fiorentino si è regalato una civetteria lessicale per così dire identitaria: «Per non dire babbo».
I nostri figli. O anche «i nostri ragazzi». La reiterata espressione, di toccante valenza famigliare, ha introdotto e rafforzato argomenti anche ragionevoli, ma «aveva pure il senso di ricercare un accordo trasversale diretto a tutti i senatori-genitori.
Struggente, devastante. Curiosa coppia di aggettivi che due volte sono comparsi nel discorso. Romantico il primo, apocalittico il secondo.
Persone. Sostantivo molto usato e mai a sproposito. Probabilmente rivelatore della cultura cattolica che sta nel background di Renzi. Si sente l’eco di Mounier e si adatta bene al tono discorsivo.
Destra, Sinistra. La prima mai citata. La seconda una sola volta, nella replica.
Slides. Anglismo esorbitante. Si poteva dire: diapositive.
Scuola, insegnanti. La parte più personale. Essendo la signora Agnese una professoressa si sentiva l’eco, e anche la vitalità, di tanti discorsi in famiglia.
Fiatone. Una dei tanti termini del sermo humilis, ovvero parla anche in Parlamento come mangi: «tirar via», «giocatevele», «le bandierine», «una pizza e una birra».
Racconto. La politica renziana persegue la tecnica e un po’ anche la filosofia della narrazione, o story-telling che dir si voglia. La bambina figlia di immigrati, le telefonate ai marò, alla signora sfigurata dal vetriolo, all’amico disoccupato. Un modo per andare alle questioni con lo slancio della prima persona.
Buon lavoro a tutti. La conclusione della replica come un saluto. Un tempo si diceva «Viva l’Italia» o anche «Iddio salvi l’Italia». La speranza che un più semplice augurio funzioni comunque.
25 febbraio 1944
Vorrei credere oltre,
Oltre che morte ti ha disfatta.
Vorrei poter dire la forza
Con cui desiderammo allora,
Noi già sommersi,
Di potere ancora una volta insieme
Camminare liberi sotto il sole.
(Il 25 febbraio 1944 è la data dell’ingresso di Levi nel campo di prigionia di Buna-Monowitz Auschwitz III)
Il cattivo tedesco e il bravo italiano
Ecco un’occasione da cogliere al volo.
Il 2014 si è aperto alla luminosa insegna degli «Italiani brava gente», la solita autonarrazione vittimistica e tossica su cui si basano tanto le versioni dominanti della vicenda «due Marò», quanto il discorso dominante sullo spettacolo Magazzino 18 di Simone Cristicchi. L’Italiano, chiunque e ovunque egli sia, va rappresentato come buono e come vittima: vittima dello straniero, delle circostanze, della sfortuna, di “traditori”…
Le parti di storia che vedono – o anche solo potrebbero vedere – l’Italiano nel ruolo di carnefice vanno minimizzate, quando non completamente rimosse. E’ sempre colpa di qualcun altro, sono «loro» ad avercela con noi.
Miliardi di miliardi di parole stampate, migliaia di ore di programmazione televisiva sui marò, ma è rarissimo udire o leggere i nomi di Ajesh Pinky e Selestian Valentine, i due pescatori uccisi in quel braccio di mare da colpi d’arma da fuoco partiti dalla petroliera Enrica Lexie.
[Potrà sembrare strano a chi abbia visto solo la montagna di fandonie, complottismi e sensazionalismo e non le notizie sepolte sotto, ma questo è quanto emerge dalla perizia balistica indiana alla quale hanno assistito tecnici italiani. La premessa che gli spari siano partiti da armi in dotazioni ai marò è accettata dalla difesa italiana.
Del resto, la maggior parte degli italiani non sa nemmeno che il governo italiano ha risarcito preventivamente (già due anni fa) le famiglie dei pescatori, che dopo l’elargizione non si sono costituite parte civile.]
Evidentemente le due vittime (quelle vere) sono in fondo non-persone, straccioni, per giunta «di colore», quindi a un livello di umanità inferiore a quello dei «nostri ragazzi». Un po’ come siamo stati considerati noialtri in vicende come il Cermis o l’uccisione di Nicola Calipari, ma l’Italiano, avvelenato com’è dal provincialismo e dalla cattiva memoria, non è mai in grado di rovesciare lo sguardo, di riconoscere se stesso nei panni dell’Altro.
Analogamente, perché il dibattito sulle foibe e sul cosiddetto «Esodo» – con la E pseudobiblicamente maiuscola, altrimenti dove va a finire la sua Unicità, dove va a finire l’italocentrismo? – possano proseguire nelle attuali forme, è necessario rimuovere o comunque minimizzare (magari liofilizzandola in cinque minuti cinque, per poi passare all’usuale vittimismo) una buona fetta di storia:
– la persecuzione di sloveni e croati dopo l’annessione della Venezia Giulia nel 1918;
– l’italianizzazione forzata perseguita dalle autorità savoiarde prima e fasciste poi: cambio dei cognomi, dei toponimi, chiusura dei giornali in lingua non italiana, scioglimento coatto delle associazioni e istituzioni delle comunità slovene e croate, divieto di scrivere in sloveno e croato sulle lapidi dei propri cari, e così via;
– la ruberia delle terre di sloveni e croati per darle a coloni italiani, courtesy by Ente Tre Venezie (e magari il nipote oggi dice «Mio nonno aveva la terra in Istria!», tacendo o ignorando come l’aveva avuta!);
– i processi-farsa e le condanne a morte comminate dal Tribunale speciale a Trieste e Pola;
– l’occupazione tedesco-italiana della Jugoslavia nel 1941;
– la deportazione di civili sloveni, croati, serbi, montenegrini ecc. in campi di concentramento (sparsi anche nella nostra Penisola) dove morivano come mosche.
E l’elenco sarebbe ancora lungo.
Queste cosa sono, sofferenze di serie B? E quelle degli esuli “giuliano-dalmati” sono di serie A? Non lo credo, e nemmeno vale il viceversa. Fatto sta, però, che foibe ed «Esodo» meritano una giornata commemorativa ad hoc e puntate su puntate di Porta a porta, mentre si è boicottato quasi ogni tentativo di far conoscere le responsabilità e i crimini dell’Italiano fuori dai recinti del sapere specialistico. Va sempre ricordata la censura Rai contro questo documentario:http://youtu.be/2IlB7IP4hys
Da quasi un anno porto in giro per l’Italia (anche) queste storie, perché sono parte essenziale del libro Point Lenana, che ho scritto insieme a Roberto Santachiara. A proposito, oggi, allo spazio sociale “La Boje!” di Mantova, farò la settantunesima presentazione di questo «oggetto narrativo non-identificato» (e WM2 farà la chissaquantesima di Timira).
A pag. 592 di Point Lenana, nella sezione intitolata «It’s been a long strange trip», c’è scritto:
«Mentre chiudevamo Point Lenana è uscito il libro di F. Focardi Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della Seconda guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari 2013. Non abbiamo fatto in tempo a leggerlo, ma lo segnaliamo sulla fiducia.»
Ebbene, se nel frattempo qualcuno lo ha letto fidandosi di noi, converrà che la segnalazione era giusta e doverosa.
Da qui, l’occasione da cogliere al volo a cui accennavo all’inizio: proprio oggi, su Carmilla, Anna Luisa Santinelli pubblica la densa, notevole, chiarissima intervista che ha fatto a Filippo Focardi. E com’era doveroso segnalare il libro, anche a scatola chiusa, così è doveroso linkare l’intervista. Buona lettura.
(dal sito http://www.wumingfoundation.com)
Alvaro Bari: un pilota veneziano nella Resistenza feltrina
 A Feltre, nell’Aula Magna dell’istituto “A. Colotti”, sabato 1 marzo 2014 alle ore 11 ci sarà la presentazione del libro “Alvaro Bari – Un pilota veneziano nella Resistenza feltrina”. Saranno presenti gli autori Aurelio De Paoli e Renato Vecchiato.
A Feltre, nell’Aula Magna dell’istituto “A. Colotti”, sabato 1 marzo 2014 alle ore 11 ci sarà la presentazione del libro “Alvaro Bari – Un pilota veneziano nella Resistenza feltrina”. Saranno presenti gli autori Aurelio De Paoli e Renato Vecchiato.
Questo il prologo di Renato Vecchiato:
Aurelio ed io, nell’autunno del 2012, ci siamo ritrovati in un incontro conviviale tra ex studenti. Accomunati da reciproca curiosità per le nostre radici storiche, c’incamminammo con la conversazione, sul tema delle lotte partigiane della sua terra, il Feltrino. L’argomento incontrò il mio interesse sia per la conoscenza dell’argomento sia per l’ammirazione che nutro, da diversi anni, per la leggendaria figura di comandante partigiano, del “comandante Bruno”, l’ingegnere Paride Brunetti, da poco deceduto. Un uomo che segnò la storia della Resistenza di Feltre e non solo. Così, dopo esserci scambiati reciproche informazioni storiografiche e opinioni personali sulla particolare complessità storica di quei tormentati venti mesi di guerra nel Feltrino, Aurelio mi comunicò di aver iniziato una ricerca su alcuni specifici episodi, in particolare su un giovane Tenente pilota ucciso dai nazi – fascisti vicino a casa sua e con giusto orgoglio m’informò che aveva già raccolto le testimonianze di alcuni anziani e di partigiani.
«Pensa, conosco personalmente un ex – aviere, già Capo Nucleo della nostra Associazione Arma Aeronautica (AAA), che aveva incontrato più volte questo Tenente pilota!» e, con un tono di sfottò etnico campanilistico, affermò: «E son sicuro che neanche giù, da voi a Venezia, si hanno notizie di questo tosàt morto per la libertà!»
«Ma come si chiamava?»
«Tenente pilota Bari Alvaro», scandì con tono militare e aggiunse «trucidato, assieme ad un altro, dai nazifascisti su di un ponte sul Piave, quello che collega Busche a Cesana».
«Bari? Conosco un medico con questo cognome…».
Così, aperta la breccia, Aurelio continuò. Il suo interessamento a quell’avvenimento era iniziato qualche tempo prima. Aveva ben presente la lapide posta all’interno dello storico Istituto Colotti che ricorda il «diplomato Alvaro Bari, il partigiano combattente “Cristallo” morto a Lentiai» quando fu incoraggiato dal Maresciallo dei Carabinieri, Stefano Vagnozzi, a raccogliere ulteriori informazioni su quel giovane. Il fatto di essere allora Capo Nucleo dell’AAA e di abitare poco lontano dal luogo della tragedia lo stimolò ad avviare la ricerca tra gli anziani. Dopo diversi contatti, la sorte lo fece incontrare con un anonimo e impaurito testimone oculare della tragedia. Un anziano che ebbe allora l’onere di aiutare il padre falegname, come lui, a costruire le casse da morto per quei due sfortunati sconosciuti. Con questa straordinaria testimonianza la ricerca si consolidò con l’acquisizione presso il Comune di Lentiai delle copie integrali dei certificati di morte di Alvaro Bari e di Giorgio Gherlenda, il suo compagno di sventura. E in questi preziosi documenti trovò trascritti i verbali ufficiali di ritrovamento che confermavano la testimonianza.
Aurelio terminò dicendomi di essere un po’ preoccupato perché non voleva turbare con la sua ricerca la sensibilità dei famigliari di Alvaro. Mi chiese allora di verificare se c’era qualche parentela con i miei conoscenti e, se ci fosse stata, di sentire la loro disponibilità a riaprire quella dolorosa ferita per ricordarne la memoria.
La fortuna l’ha assistito una seconda volta. La casualità aveva fatto incontrare i nostri interessi rispetto a questa dolorosa storia. Un Feltrino e un Veneziano, per un eroe veneziano d’origine ma feltrino d’adozione.
Così, dopo aver avuto da due nipoti, Mario e Giorgio Bari, il ringraziamento per il suo impegno a far conoscere il loro congiunto, ho dato anch’io la mia disponibilità a proseguire e sviluppare la sua bozza iniziale, per la quale era stato già incoraggiato anche dalle parole del Vice Presidente della Sezione AAA di Treviso, il Ten. Col. Augusto Costantini :
[…] Aurelio contribuisce a farci conoscere queste storie ingiustamente sconosciute o dimenticate e che comunque non dovrebbero mai più ripetersi. Il lavoro, scritto con passione, è molto interessante […]»
Aurelio non ha solo il merito di aver promosso l’iniziativa, ma anche di aver coinvolto i seguenti testimoni feltrini:
– Romildo De Bastiani, artigiano muratore di Pont di Feltre.
– Carlo Gris, artigiano, figlio del comandante partigiano Oreste, “Tombion” di Menin di Cesiomaggiore.
– Sergio Samiolo, partigiano “Sam”, taxista, ex – aviere aiuto autista, amico di Alvaro. Capo nucleo della AAA di Feltre dal 1989 al 2003.
– Umberto Tatto, partigiano “Leone”, giovanissima guida nella ritirata della Brigata Gramsci durante il rastrellamento nazifascista delle Vette feltrine; capo cantiere dell’impresa “Lodigiani”.
– Mauro Velo, falegname, testimone oculare della fucilazione di Alvaro Bari e di Giorgio Gherlenda.
Il mio impegno si è focalizzato soprattutto nella ricerca documentale e bibliografica riguardante la vita di Alvaro, breve ma densa dei tragici avvenimenti dell’epoca. Per fare questo ho coinvolto molte altre persone, tra i primi i nipoti Mario e Giorgio Bari; a quest’ultimo va anche il merito di aver rintracciato il fascicolo del processo a Niedermayer presso il Tribunale Militare di Verona, oltre che aver seguito con sensibilità e passione il lavoro.
Tra i tanti contributi di collaborazione personalmente ricevuti, ricordo con gratitudine quelli forniti: dalle signore Fiorenza Lovera e Cristina Gherlenda (nipoti di Gherlenda); dal dirigente scolastico e dalla direttrice amministrativa dell’istituto Andrea Colotti di Feltre; dai funzionari dei diversi Comuni interpellati (tra i quali Feltre, Lentiai, Cesiomaggiore, Fiera di Primiero, Venezia, San Stino di Livenza, Noale, Loreggia); dai responsabili dei due Istituti di storia della Resistenza: Isbrec (Belluno) e Ivsrec (Padova); dai parroci di Pez, Lentiai e Primiero; dai funzionari del Ministero della Difesa (Divisione Documentazione Aeronautica di Roma, Centro di documentazione militare di Padova, Tribunale Militare di Verona) e, (non ultimi!) dagli storici citati in bibliografia, specialmente Giuseppe Sittoni.
Un ringraziamento particolare:
alla professoressa Liana Bortolon, coetanea ed amica d’infanzia della giovane fidanzata di Alvaro, per avermi concesso un’intervista telefonica;
al professor Giovanni Perenzin per aver fornito, da attento e scrupoloso studioso feltrino della Resistenza, molte e dettagliate osservazioni nella stesura finale del libro.
Renato Vecchiato
17 febbraio 1992: arresto di Mario Chiesa
 Lunedì 17 febbraio 1992, ore 17,30. Un imprenditore di 32 anni, Luca Magni, si presenta in via Marostica 8 a Milano, nell’ufficio di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio. Magni è titolare di una piccola impresa di pulizie, la Ilpi di Monza, che lavora anche per il Trivulzio, la storica casa di ricovero per anziani fondata nel Settecento. Chiesa è un esponente del Partito socialista italiano e non nasconde le sue ambizioni: sogna di diventare, in un futuro che spera prossimo, sindaco di Milano. Dopo mezz’ora di anticamera, Magni viene ricevuto. Deve consegnare al presidente 14 milioni, la tangente pattuita su un appalto da 140 milioni. Nel taschino della giacca ha una penna che in realtà è una microspia. In mano stringe la maniglia di una valigetta che nasconde una telecamera. «A dir la verità – ricorda Magni – avevo una paura pazzesca, ero agitatissimo. L’ingegner Chiesa era al telefono e io sono rimasto dieci minuti in piedi ad aspettare che finisse di parlare. Poi gli ho dato una busta che conteneva 7 milioni. Gli ho detto che gli altri sette per il momento non li avevo.» Chiesa non reagisce. Domanda soltanto: «Quando mi porta il resto?». «La settimana prossima», risponde concitato Magni. Poi saluta. E, uscendo, quasi si scontra con un carabiniere in borghese.
Lunedì 17 febbraio 1992, ore 17,30. Un imprenditore di 32 anni, Luca Magni, si presenta in via Marostica 8 a Milano, nell’ufficio di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio. Magni è titolare di una piccola impresa di pulizie, la Ilpi di Monza, che lavora anche per il Trivulzio, la storica casa di ricovero per anziani fondata nel Settecento. Chiesa è un esponente del Partito socialista italiano e non nasconde le sue ambizioni: sogna di diventare, in un futuro che spera prossimo, sindaco di Milano. Dopo mezz’ora di anticamera, Magni viene ricevuto. Deve consegnare al presidente 14 milioni, la tangente pattuita su un appalto da 140 milioni. Nel taschino della giacca ha una penna che in realtà è una microspia. In mano stringe la maniglia di una valigetta che nasconde una telecamera. «A dir la verità – ricorda Magni – avevo una paura pazzesca, ero agitatissimo. L’ingegner Chiesa era al telefono e io sono rimasto dieci minuti in piedi ad aspettare che finisse di parlare. Poi gli ho dato una busta che conteneva 7 milioni. Gli ho detto che gli altri sette per il momento non li avevo.» Chiesa non reagisce. Domanda soltanto: «Quando mi porta il resto?». «La settimana prossima», risponde concitato Magni. Poi saluta. E, uscendo, quasi si scontra con un carabiniere in borghese.
Mentre l’imprenditore telefona a casa («Per tranquillizzare mia madre e mia sorella, che sapevano dell’operazione ed erano preoccupate per me»), una squadretta di investigatori blocca il presidente del Trivulzio, che capisce di essere caduto in trappola. «Questi soldi sono miei», azzarda. «No, ingegnere, questi soldi sono nostri», replicano gli uomini in divisa. Allora chiede di andare in bagno e si libera delle banconote di un’altra tangente da 37 milioni, incassata poco prima, gettandole nella tazza del gabinetto. Poi viene arrestato e portato nel carcere di San Vittore.
L’intervento è stato preparato con cura. Le prove sono schiaccianti: una ogni dieci delle banconote di Magni è stata firmata da un lato dal capitano dei carabinieri Roberto Zuliani, dall’altro dal sostituto procuratore Antonio Di Pietro. La ditta di Magni, che si occupa di speciali trattamenti ospedalieri, lavora per il Pio Albergo Trivulzio da qualche anno. Nel 1990, con i primi appalti consistenti, sono arrivate anche le prime richieste di denaro. Racconta Magni: «I soldi Chiesa me li ha chiesti con quattro parole secche, com’è sua abitudine: “Mi deve dare il 10 per cento”». In meno di due anni l’imprenditore porta a Chiesa una quarantina di milioni, in sei o sette consegne, sempre in contanti, dentro una busta bianca. «Io non immaginavo certo che cosa sarebbe successo dopo la mia decisione di andare dai carabinieri. Per me era un problema economico. Il 10 per cento è troppo, anche perché nel nostro settore non possiamo recuperare gonfiando i prezzi. E poi le buste Chiesa le voleva subito, mentre noi i pagamenti li vedevamo molti mesi dopo. Era una situazione insostenibile.»
Così Magni chiede aiuto all’Arma. Il 13 febbraio telefona alla caserma milanese di via Moscova. Il capitano Zuliani gli fissa un appuntamento per le 10 del giorno seguente, venerdì 14. Lo ascolta, raccoglie la sua denuncia e la presenta al magistrato con cui lavora: Di Pietro. Il pm e l’ufficiale preparano il blitz per il lunedì: quel giorno Di Pietro è di turno, quindi l’inchiesta sarà assegnata a lui. L’appuntamento è per le 13 del 17 febbraio, alla caserma di via Moscova. Luca Magni arriva con la sua auto Mitsubishi e con i suoi 7 milioni. Il capitano lo accompagna subito a palazzo di giustizia: «Ero un po’ teso – ricorda l’imprenditore – perché non mi aspettavo di incontrare un magistrato. Però mi sono subito tranquillizzato, perché Di Pietro è stato molto gentile. Ha fatto uscire dalla sua stanza tutti quelli che vi stavano lavorando, mi ha messo a mio agio e mi ha chiesto di raccontargli i fatti, senza alcun atteggiamento inquisitorio».
In caserma, le banconote vengono siglate e fotocopiate. Si prova la penna- trasmittente e la valigetta-telecamera (che alla fine non risulterà granché utile). Poi un corteo di quattro macchine, la Mitsubishi di Magni e tre auto dei carabinieri, parte per il Pio Albergo Trivulzio (che i milanesi chiamano affettuosamente «Baggina» perché ha sede sulla strada che porta a Baggio). Sta nascendo Mani pulite, l’inizio della fine di un sistema politico. Ma nessuno, quel giorno, può ancora immaginarlo. (da “Il Fatto Quotidiano)
Venerdì 14 febbraio: Domenico Gallo “Da sudditi a cittadini”
 La Costituzione è – dovrebbe essere – il patto, la regola fondamentale per la convivenza di un popolo. Un insieme di valori, di principi e di norme vincolanti. E invece, sempre più spesso, la si considera una sorta di reliquia. Nella migliore delle ipotesi essa viene considerata un simbolo, come la bandiera o l’inno nazionale, ma non incide sulla vita quotidiana dei cittadini e delle istituzioni. C’è chi la considera un documento storico superato, suscettibile di essere modificato a piacimento. Il libro di Domenico Gallo – magistrato e giurista di grande cultura storica e politica – reagisce a questo atteggiamento e lo fa ricostruendo la storia, i movimenti, gli eventi che hanno portato alla Costituzione; evidenziando chi l’ha voluta e chi l’ha ostacolata; esplicitando la portata dei principi in essa affermati. Tutto questo con l’ausilio di materiali storici, documenti, filmati raccolti in uno specifico CD-Rom allegato. Un libro per tutti, particolarmente prezioso per studenti e insegnanti.
La Costituzione è – dovrebbe essere – il patto, la regola fondamentale per la convivenza di un popolo. Un insieme di valori, di principi e di norme vincolanti. E invece, sempre più spesso, la si considera una sorta di reliquia. Nella migliore delle ipotesi essa viene considerata un simbolo, come la bandiera o l’inno nazionale, ma non incide sulla vita quotidiana dei cittadini e delle istituzioni. C’è chi la considera un documento storico superato, suscettibile di essere modificato a piacimento. Il libro di Domenico Gallo – magistrato e giurista di grande cultura storica e politica – reagisce a questo atteggiamento e lo fa ricostruendo la storia, i movimenti, gli eventi che hanno portato alla Costituzione; evidenziando chi l’ha voluta e chi l’ha ostacolata; esplicitando la portata dei principi in essa affermati. Tutto questo con l’ausilio di materiali storici, documenti, filmati raccolti in uno specifico CD-Rom allegato. Un libro per tutti, particolarmente prezioso per studenti e insegnanti.
Venerdì 14 febbraio alle ore 20.45 Domenico Gallo sarà presente nella sala conferenze di Villa Errera a Mirano per presentare il suo libro. Introduzione a cura di Francesco Baicchi, coordinatore nazionale della “Rete per la Costituzione”.
http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/stampa.php?id=132



