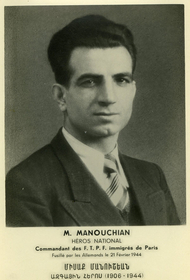Una guerra nucleare. Fu quello che si sfiorò nel 1983, ma che è rimasto all’oscuro. Fino ad oggi. Nel novembre del 1983, gli Usa e i loro alleati della Nato condussero una serie di esercitazioni militari, denominate “Operation Able Archer”, talmente realistiche dal convincere i russi della possibilità di un attacco nucleare sul loro territorio. Quando l’allora governo conservatore britannico venne informato del rischio dai servizi segreti, il premier Margaret Thatcher ordinò ai suoi funzionari di fare pressione sugli americani affinché un simile errore non si ripetesse.
Una guerra nucleare. Fu quello che si sfiorò nel 1983, ma che è rimasto all’oscuro. Fino ad oggi. Nel novembre del 1983, gli Usa e i loro alleati della Nato condussero una serie di esercitazioni militari, denominate “Operation Able Archer”, talmente realistiche dal convincere i russi della possibilità di un attacco nucleare sul loro territorio. Quando l’allora governo conservatore britannico venne informato del rischio dai servizi segreti, il premier Margaret Thatcher ordinò ai suoi funzionari di fare pressione sugli americani affinché un simile errore non si ripetesse.
Tutto questo è stato rivelato grazie a una serie di documenti top secret, ora desecretati, ottenuti da Peter Burt, direttore del Nuclear Information Service (Nis), un’organizzazione impegnata contro la proliferazione delle armi nucleari. “Questi documenti testimoniano un momento di svolta nella storia moderna, il punto nel quale un allarmato governo Thatcher si rende conto che bisogna mettere fine alla Guerra Fredda e inizia a convincere gli alleati americani a fare altrettanto”, spiega Burt al quotidiano britannico Guardian.
Able Archer, che prevedeva lo spostamento di 40mila militari Usa e della Nato attraverso l’Europa occidentale ed era coordinato da un sistema criptato di comunicazioni, immaginava uno scenario nel quale le Forze Blu (Nato) intervenivano a difesa dei loro alleati dopo che le Forze Arancioni (Patto di Varsavia) avevano invaso la Jugoslavia a seguito di sommovimenti politici interni. Le Forze Arancioni, secondo lo scenario ipotizzato nell’esercitazione, avevano poi anche invaso la Finlandia, la Norvegia e la Grecia. In breve, il conflitto immaginario subiva un’escalation che prevedeva l’uso di armi chimiche e nucleari.
A quanto riporta l’Adnkronos, secondo Paul Dibb, che in passato è stato direttore della Joint Intelligence Organisation (Jio), gli ex servizi di intelligence australiani, l’esercitazione militare Nato del 1983 costituì per la pace nel mondo una minaccia ancora più grave di quella della crisi dei missili di Cuba del 1962. “Able Archer avrebbe potuto dare il via alla catastrofe definitiva”.
Ad aumentare il rischio di una fatale incomprensione tra i due schieramenti era soprattutto il contesto storico nel quale avvenne l’esercitazione. Due mesi prima, nel settembre del 1983, i russi avevano abbattuto un Boeing 747 delle linee aeree coreane, uccidendo le 269 persone a bordo, credendo che l’aereo fosse un velivolo spia americano. In precedenza, il presidente Usa Ronald Reagan aveva pronunciato il famoso discorso nel quale definiva l’Unione Sovietica “l’impero del male”, annunciando i suoi piani di “Guerre Stellari” per la realizzazione di un sistema di difesa strategico.
La diffidenza reciproca tra i due blocchi era quindi ai massimi livelli. Dopo l’avvio dell’esercitazione della Nato, il Cremlino diede l’ordine di decollo a una decina di bombardieri nucleari dislocati in Germania est e Polonia. Circa 70 rampe di lancio dei missili SS-20 vennero poste in stato di allerta, mentre i sottomarini sovietici armati con missili nucleari vennero inviati sotto i ghiacci dell’Artico, per sfuggire ai sistemi di rilevamento della Nato. All’inizio, i comandanti della Nato pensarono che le mosse sovietiche fossero a loro volta una esercitazione militare ordinata da Mosca.
I documenti ottenuti da Peter Burt indicano invece quanto fatale potesse rivelarsi quell’equivoco. In un rapporto desecretato del Joint Intelligence Commitee (Jic) britannico si legge: “Non possiamo escludere la possibilità che almeno alcuni funzionari e ufficiali sovietici possano avere male interpretato Able Archer 83 e considerino altre esercitazioni nucleari come una reale minaccia”.
L’allora segretario di Downing Street, Sir Robert Armstrong, in un briefing alla Thatcher spiegò che la risposta sovietica non aveva le caratteristiche di un’esercitazione perchè “avveniva durante un’importante festività sovietica, aveva la forma di una reale attività militare e di allerta, non solo di un’esercitazione ed era limitata geograficamente in un’area, l’Europa centrale, coperta dall’esercitazione della Nato”.
In sintesi, l’Unione Sovietica temeva un attacco della Nato mascherato da esercitazione militare. Gran parte delle informazioni di intelligence contenute nel briefing per il primo ministro, inoltre, provenivano da Oleg Gordievskij, l’ex doppio agente segreto al servizio dell’intelligence britannica. La Thatcher, rivelano ancora i documenti, prese talmente sul serio la minaccia derivante da un catastrofico malinteso, che ordinò ai suoi funzionari di “considerare quanto può essere fatto per impedire il rischio che l’Unione Sovietica reagisca in maniera spropositata a causa di una interpretazione sbagliata delle intenzioni occidentali”. Il premier chiese quindi di “prendere urgentemente” misure per convincere gli americani del rischio.
Il ministero della Difesa e quello degli Esteri stesero allora una bozza di documento da sottoporre all’attenzione di Washington, nella quale si proponeva che d’ora in avanti “la Nato dovrebbe informare regolarmente l’Unione Sovietica sulle previste attività di esercitazioni militari che comprendono simulazioni nucleari”. Il briefing che tanto allarmò la Thatcher finì anche sulla scrivania di Reagan, che volle incontrare personalmente la spia Gordievskij. Secondo le ricostruzioni, il presidente Usa rimase talmente colpito dagli argomenti presentatigli, che si convinse della necessità di un approccio diverso con l’Unione Sovietica.
da http://www.huffingtonpost.it