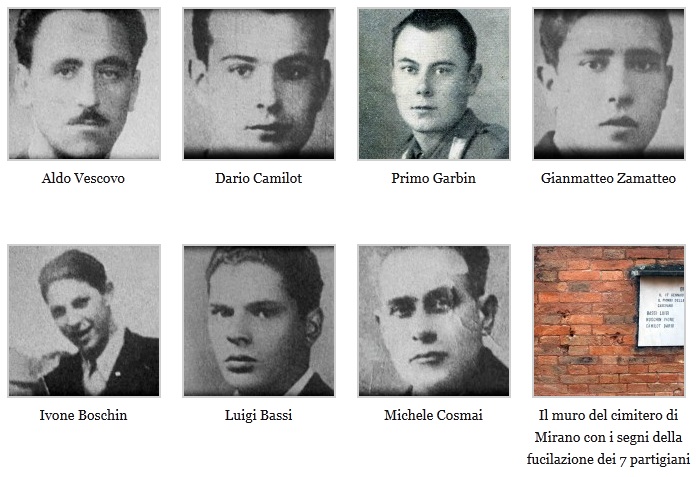Ha condotto l’azione «con calma, implacabile energia ed intelligenza». Sono le precise parole di una proposta di encomio solenne per un tenente colonnello che durante l’ultima guerra guidò un’operazione militare nella Grecia occupata. Le parole le scrisse il comandante della divisione Pinerolo, il generale Cesare Benelli. L’ufficiale da encomiare era il tenente colonnello De Paula. Ma l’ufficiale non aveva guidato un’azione particolarmente rischiosa o impegnativa. Non aveva combattuto contro «soverchianti forze nemiche», come spesso si legge nelle motivazioni di medaglie ed encomi. Aveva “solo” messo a ferro e fuoco un paese, Domenikon, in Tessaglia, uccidendo gli uomini, bruciando le case, deportando donne e bambini. Un crimine di guerra commesso da soldati italiani sul quale sta adesso indagando la procura militare di Roma.
Ha condotto l’azione «con calma, implacabile energia ed intelligenza». Sono le precise parole di una proposta di encomio solenne per un tenente colonnello che durante l’ultima guerra guidò un’operazione militare nella Grecia occupata. Le parole le scrisse il comandante della divisione Pinerolo, il generale Cesare Benelli. L’ufficiale da encomiare era il tenente colonnello De Paula. Ma l’ufficiale non aveva guidato un’azione particolarmente rischiosa o impegnativa. Non aveva combattuto contro «soverchianti forze nemiche», come spesso si legge nelle motivazioni di medaglie ed encomi. Aveva “solo” messo a ferro e fuoco un paese, Domenikon, in Tessaglia, uccidendo gli uomini, bruciando le case, deportando donne e bambini. Un crimine di guerra commesso da soldati italiani sul quale sta adesso indagando la procura militare di Roma.
Tutto avviene il 16 febbraio 1943, in Tessaglia, appunto. Un’autocolonna italiana che trasporta viveri viene attaccata da quello che viene definito un “gruppo di banditi”, cioè di partigiani greci che combattono contro gli occupanti italiani. La battaglia termina con la rotta degli assalitori. Ma da dove sono arrivati i partigiani? La località abitata più vicina è Domenikon e gli italiani immaginano che da lì siano venuti i “banditi”. Gli uomini della Pinerolo agiscono immediatamente. Radunano e massacrano tutti i maschi di più di 14 anni che vi abitano. Le poche case vengono date alle fiamme. La chiesa viene risparmiata, le donne avviate in un campo di concentramento. Il generale Benelli si vanta di quell’azione, dice che è «esempio e monito per il futuro» e nelle conclusioni del rapporto scrive che «le perdite sono le seguenti, da parte nostra. Morti in combattimento:
truppa 8: morto in ospedale in seguito alle ferite, truppa 1. Feriti: 2 ufficiali, truppa 13. Da parte dei greci. Morti durante lo scontro: 8. Sbandati raggiunti e passati per le armi dalla scorta dell’autocolonna: 7. Rastrellati dalla compagnia di rinforzo e passati per le armi: 16. Passati per le armi perché cercavano di fuggire dall’accerchiamento: 4. Passati per le armi da reparto inviato da Tyrnavos: 8. Passati per le armi a Damasi: 97 (sono i cittadini di Domenikon, ndr.). In totale 140 sudditi greci deceduti».
I documenti su questa storia erano stipati in quello che può essere definito un “carrello della vergogna”. Un carrello grande, a due piani, di quelli che servono a portare faldoni da un ufficio all’altro e nascosto in un angolo della Procura militare, non molto lontano dall’“armadio della vergogna”. L’armadio aperto nel 1994 e di cui parlò per primo “l’Espresso”con l’articolo “Dieci, cento, mille Ardeatine” di Alessandro De Feo e mio. Un armadio della procura militare rimasto per decenni con le ante rivolte verso il muro e dentro, «archiviati provvisoriamente», 695 fascicoli sulle stragi commesse in Italia dai nazisti. Vi vennero chiusi nel 1960 per una sorta di patto segreto tra Italia e Germania. Nessun processo per i nazisti, nessun processo, in cambio, contro i fascisti colpevoli di crimini di guerra nei paesi aggrediti da Mussolini. Nel carrello della vergogna, infatti, insieme al fascicolo sulla strage di Domenikon ce ne sono molti altri relativi alle tante stragi commesse, durante l’ultima guerra, dai militari italiani.
Il fascicolo su Domenikon adesso è sul tavolo del procuratore militare di Roma, Marco De Paolis. E i fatti sono ricostruiti nel diario della divisione Pinerolo che, comandata dal generale Cesare Benelli, era di stanza nella Grecia occupata. A far riemergere questa storia è stato un documentario di Giovanni Donfrancesco (mai trasmesso dalla Rai), “La guerra sporca di Mussolini”. La Procura militare di Roma apre l’inchiesta, ma poi
la chiude frettolosamente con doppia motivazione: «Il generale Benelli è deceduto e manca la parità di tutela penale da parte dello Stato nemico a norma dell’art.165 del Codice militare di guerra». A parte il fatto che sarebbe stato opportuno scrivere Stato ex nemico, molti magistrati contestano l’applicabilità di quell’articolo, un articolo chiamato “salva-tutti”, perché riguarderebbe il rapporto tra militari e militari e non tra militari e civili.
Ma per fortuna il tempo non basta a soffocare l’anelito di giustizia che è una delle colonne portanti della democrazia. E così a Marzabotto, nel giorno della ricorrenza della strage, l’8 ottobre di due anni fa, un distinto signore avvicina l’attuale procuratore militare della Repubblica di Roma, Marco De Paolis. Si chiama Efstathios Psomiades, è il rappresentante delle famiglie delle vittime di Domenikon. Chiede giustizia, fa un discorso di questo tipo: qui in Italia, a gran voce, si chiede che vengano puniti i criminali nazisti responsabili di questo e di tanti altri massacri. Ma i fascisti sono ugualmente colpevoli di delitti simili. Perché non si procede anche contro di loro? Al suo ritorno a Roma De Paolis consulta quei vecchi fascicoli e riapre l’inchiesta chiusa circa cinque anni prima dal suo predecessore Antonino Intelisano, poi promosso al massimo grado di procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Va ricordato che De Paolis ha riavviato le inchieste su Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, Fivizzano e molte
altre stragi, chiedendo ed ottenendo, sinora, sessanta ergastoli. Di nazisti colpevoli ne sono rimasti in vita una quarantina, ma Germania e Austria non vogliono “disturbarli”, vivono tranquillamente nelle loro case.
Per Domenikon De Paolis ha aperto un procedimento a carico di ignoti alla ricerca di qualcuno della divisione Pinerolo ancora in vita. A oggi, a quanto pare, i carabinieri hanno scovato solo un novantacinquenne, ex sottotenente di quella divisione, che però non si trovava allora in quel teatro di operazioni. Ma l’inchiesta continua. (di Franco Giustolisi da “L’Espresso)
La guerra sporca di Mussolini: http://youtu.be/_ttQKhut4vo