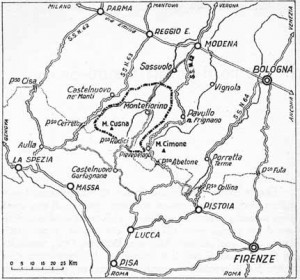È morta a Roma, all’ età di 92 anni, Anna Maria Levi, la sorella di Primo Levi. Nel dare la notizia della sua scomparsa, Moked. it, il portale dell’ ebraismo italiano, ha scritto che viveva nella capitale «ormai da lungo tempo assieme a Julian Zimet, un ebreo americano attivo nel mondo del cinema». Era minore di due anni rispetto all’ autore di Se questo è un uomo, nato nel 1919 ( e morto nel 1987) , che fu sempre molto legato a lei. Di carattere allegro e aperto, Anna Maria rispecchiava un po’ , in tutto ciò, il padre Cesare, un ingegnere elettrotecnico sposatosi nel 1918 con Ester Luzzati, che viene descritto da Primo come uomo estroverso e moderno, amante dei libri e del buon vivere, poco curante delle cose di famiglia. Ernesto Ferrero, studioso di Leviea lungo dirigente della sua casa editrice, l’ Einaudi, ricorda Anna Maria come «una donna di una simpatia straordinaria, spiritosa ed estroversa, diversa da Primo, timido e riservato. Amava i suoi nipotini, aveva un forte legame col fratello. La crescente fama di Primo, in ogni caso, era stata vissuta da lei con discrezione e riserbo; da parecchi anni, oltretutto, si era trasferita a Roma». Solo in rare occasioni era venuta meno al riserbo. Accadde nel 1997, quando al Teatro Regio di Torino ci fu l’ anteprima mondiale de La tregua, il film che Francesco Rosi trasse dall’ omonimo romanzo. Quella sera in platea sedettero Anna Maria e i figli di Primo, Renzo e Lisetta. I giornali del tempo, in questo caso Repubblica, sottolinearono che la famiglia di Levi non aveva voluto sottrarsi a un’ opera che Primo aveva amato ancora prima che ne iniziasse la lavorazione. Lo scrittore, poco prima di morire, aveva detto: «L’ idea che da La tregua nasca un film, è una delle poche cose che in questi giorni mi dà un briciolo di felicità». Anche il giornalista Gad Lerner, che l’ ha incontrata di recente, dopo le polemiche insorte a proposito del libro Partigia di Sergio Luzzatto, ne ha tracciato su Twitter un ritratto analogo a quello di Ferrero: «L’ avevo visitata da poco, sempre acutae spiritosa. Con me, assai generosa». Anna Maria, pur amareggiata da quelle polemiche, non aveva voluto commentarle. Fin da ragazza, la sorella di Levi aveva fatto parte dei circoli ebraici torinesi animati da giovani intellettuali come Emanuele Artom, poi trucidato dai nazifascisti nell’ aprile del 1944, che avrebbero dato vita alla Resistenza nelle formazioni di Giustizia e Libertà. Fu la stessa scelta che fece Anna Maria, che aveva accompagnato Primo in Val d’ Aosta sul finire del 1943. A differenza del fratello, però, rimasto in montagna, aveva deciso di ritornare in pianura. Il futuro scrittore, entrato in una delle prime bande partigiane, venne catturato dai repubblichini a dicembre e successivamente deportato nei lager nazisti. Anna Maria, rammenta ancora Moked.it, «partecipò alla Resistenza assieme a tanti altri giovani ebrei piemontesi perseguitati», conducendo dalla fine della guerra «un’ esistenza molto discreta e al riparo dalla straordinaria notorietà internazionale conquistata dal fratello». Fu apprezzata «per il suo contributo nell’ edizione italiana di numerosi libri di grande valore, fra cui gli studi di Leon Poliakov sull’ antisemitismo». Prima di andare a Roma, aveva frequentato gli ambienti e gli amici di Primo. In una intervista a Repubblica, il sociologo Franco Ferrarotti ha rievocato: «Traducevo dall’ inglese, dal tedesco, e mi ero fidanzato con Anna Maria Levi, la sorella di Primo Levi, il quale allora stava cercando un’ occupazione da chimico e nessuno sapeva tutto quello che poi avrebbe raccontato nei suoi libri». Anna Maria è presente, conclude il portale dell’ ebraismo italiano, in una pagina di Primo, «in cui nel corso di un sogno angoscioso sembra tragicamente presagire e denunciare i tempi della manipolazione e della cancellazione della Memoria». L’ intellettuale torinese «descrive l’ allontanamento degli amici dalla sua testimonianza, lasciando proprio alla sorella il compito di abbandonarlo da ultima in una insanabile solitudine». I funerali di Anna Maria Levi si svolgeranno in forma strettamente privata.
MASSIMO NOVELLI da Repubblica