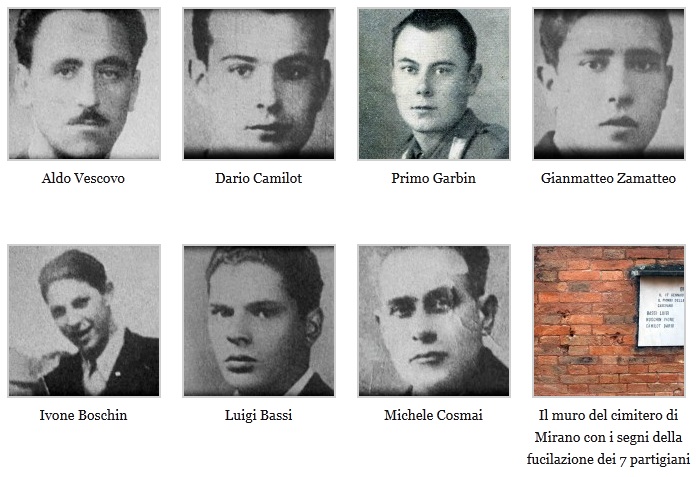“Un uomo ordinato. Il dizionario del Partigiano” di Angelo Del Boca (da “Storie della Resistenza”, Sellerio Editore)
“Un uomo ordinato. Il dizionario del Partigiano” di Angelo Del Boca (da “Storie della Resistenza”, Sellerio Editore)
In marzo iniziò lo sgelo e poco dopo cominciarono ad affiorare i corpi dei morti. Quasi ogni giorno c’era un contadino che scendeva al comando per segnalare un ritrovamento.
Erano i ragazzi morti negli scontri durante il ripiegamento invernale e che non avevamo fatto in tempo a seppellire; oppure quelli che si erano persi nella tormenta e che il freddo aveva ucciso. La montagna continuava a restituirne e fu necessario costituire una squadra che si occupasse di questa opera di pietà.
Gli oggetti che venivano trovati indosso ai morti finivano al comando, dentro buste o sacchetti: alla fine della guerra avremmo provveduto a spedirli alle famiglie.
In genere erano orologi, catenine d’oro con la medaglia del Cristo o della Vergine, anelli, amuleti, pipe, rasoi, coltelli a serramanico, qualche libro, molte fotografie di mamme e di ragazze.
Trovammo anche un diario, testi di canzoni partigiane, lettere mai spedite, testamenti. Erano documenti, questi, che eravamo costretti a leggere per cercare di identificare i morti. Ma lo facevamo con molta reticenza e con pena, perché spesso, fra le cose private della loro vita, affioravano considerazioni sulla nostralotta, e queste erano spesso ingenue, qualche volta sbagliate, a volte straordinariamente acute, e ciò ci obbligava mentalmente a dividere i morti in buoni e in meno buoni, in consapevoli e in opportunisti ed era proprio ciò che non avremmo voluto fare.
Il documento che più ci sorprese fu una sorta di dizionario, una cinquantina di voci scritte a matita su altrettanti piccoli fogli d’agenda. I fogli, per l’umidità, si erano incollati e se non fossero stati scritti a matita non si sarebbe salvato nulla. Pazientemente asciugammo foglio per foglio e alla fine cominciammo a leggere ciò che segue:
Alba – Quando spunta, può essere troppo tardi.
Alexander (Maresciallo) – Avrebbe voluto, all’inizio del secondo inverno, che fossimo spariti come talpe sottoterra. Non se l’abbia a male se gli abbiamo disobbedito: non c’erano buche a sufficienza.
Auto – Uno ci monta sopra e va finché ha fuso. La montagna è un cimitero di macchine.
Badoglio e Bonomi – Due personaggi, scialbi, che stanno al Sud, con gli americani.
Barba – Molti se la lasciano crescere, ma non sempre perché mancano di lamette. Chi la porta, automaticamente viene chiamato “Barba”. E poiché in un distaccamento sono in parecchi ad averla, uno si chiamerà “Barba I”, l’altro “Barba II”, e così via. Ad alcuni sta bene, gli fa una faccia decisa. Ad altri addolcisce gli occhi. Altri ancora, e sono i più ostinati a tenerla, fanno pensare alle capre.
Cani – Sono un vero guaio, di notte, durante le marce di trasferimento. Il primo a sentirvi dà la sveglia al vicino, e in pochi istanti la valle è tutta un abbaio. I cani dei tedeschi invece non abbaiano. Sono alti, snelli, col pelo corto. Ti inseguono per giornate, come se ti conoscessero, ti odiassero. Cani sono anche chiamati i tedeschi, per quanto si preferisca chiamarli maiali.
Cartucce – Ce ne sono poche e non bisogna sprecarle. In media, un uomo ne porta con sé 40-50, se possiede un fucile, e 120-150, se è dotato di un mitra. Quelli che ne fanno incetta, c’è da giurare che non spareranno mai un colpo.
Casa – Meglio non pensarci. Col tempo, non è poi tanto difficile.
Castagne – Dapprincipio ci sembrava impossibile, poi ci convincemmo: si può vivere soltanto di castagne. Castagne secche per ingannare l’appetito. Castagne bollite per riempire la gola. Castagnaccio per addormentare lo stomaco. Brodo di castagne per riscaldarlo.
Città – Ci stanno “gli altri”. L’hanno fortificata, seminata di cavalli di frisia, tappezzata di proclami e di manifesti insensati. Qualcuno dei nostri c’è entrato, di notte, e gli è parso di essere finito in un labirinto, in una trappola. Eppure buona parte delle persone che l’abitano è con noi.
Comandante – Lo si diventa per meriti, non per titoli di studio. Conosco un mungitore che ha ai suoi ordini un colonnello di Stato Maggiore. Di solito si affermano quando scoprono per la guerriglia un’autentica vocazione. Fanno sempre di testa loro, e raramente sbagliano. Quando sbagliano pagano di persona.
Commissario – È quello che sa tutto, anche se non possiamo sempre giurare che sia il depositario della verità. Quelli che hanno dubbi vanno da lui. E lui che ci ha detto chi sono Matteotti e Gramsci i fratelli Rosselli, e perché sono morti. Perché il fascismo è condannato. Perché noi siamo nel giusto. Perché dobbiamo combatterei.
Comunisti – Sono i più numerosi, e sono inquadrati, nelle Brigate “Garibaldi”. Gelosi delle loro zone, pretendono il rispetto dei confini e non rispondono agli appelli di aiuto, se non ne intravedono un tornaconto.
Quando ci riescono, disarmano altri reparti con il pretesto che questi non sanno battersi. A volte sono nella ragione, a volte nel torto. Politicamente i loro quadri sono i più preparati. Gli uomini si battono bene e non lo nascondono: domani, finita la guerra, continueranno a battersi per sconvolgere la vecchia struttura dello Stato prefascista e per mutare radicalmente la nostra società. Magari con una rivoluzione.
Divisa – Non ne esiste una di rigore, perciò sono tutte buone. La più corrente tuttavia è quella composta da un giubbotto, calzoni da sciatore e un berretto a visiera, come quello degli alpini tedeschi; forse perché si è rivelata la più pratica. Ma la fantasia e la vanità suggeriscono le divise più stravaganti. C’è un tizio – appare sempre a cavallo – che indossa un lungo mantello di pelle rossa foderato all’interno di pelliccia bianca; sotto ha un abito attillatissimo. Quelli che portano un fazzoletto rosso attorno al capo, alla pirata, sono migliaia. Altri portano cappelli da cow-boy, passamontagna, caschi coloniali, colbacchi, bustine, baschi,fez. Alcuni indossano la divisa della Wehrmacht, elmettoe croci di ferro comprese, e debbono farsi riconoscereper non essere presi a fucilate.
Domani – Si spera sempre che sia migliore. Che non ci siano da fare cinquanta chilometri per spostarsi da una valle all’altra. Che i tedeschi non sguinzaglino i loro cani. Che il freddo non sia troppo rigido. Che non manchi da mangiare. Che gli aerei degli alleati non ci scambino per gli “altri” (come è già avvenuto). Che non ci capiti di pensare a casa. Che sia finalmente l’ultimo giorno di questa storia.
Fossi – Non avremmo mai sospettato, qualche anno fa, che avremmo trascorso parte della nostra giornata nei fossi. Ci si nasconde prima di attaccare i convogli che transitano sulle strade; si balza dall’uno all’altro mentre ci si ritira in pianura; in mancanza di almi ripari, lo si sceglie per passarci la notte. Nelle ore di attesa si fa conoscenza coi topi, le serpi e ogni sorta di vermi; si scoprono fiori e arbusti che non si sapeva che esistessero; ci si avvede che la natura continua a fiorire, nonostante l’odio che ci circonda. Poi, per fortuna, si torna in montagna, dove viviamo nel cielo. Soltanto ora possiamo capire (e compiangere) i nostri padri che hanno fatto tutta loro guerra nelle trincee.
Fucile – Tutti preferiscono il mitra al fucile. Poi, però, finiscono per portare l’uno e l’altro. Un buon fucile colpisce a cinquecento metri, il mitra è inutile a cento. Quelli che abbiamo sono molto vecchi; l’Enfield inglese ha fatto la guera contro i boeri; il nostro ’91 ha sparato ad Adua e a Tripoli. Il più moderno è il Mauser, ma ne possediamo pochi.
Fuga – La nostra non è una guerra classica, non è una guerra di posizione e neppure di prestigio. Perciò la fuga vi è ammessa, ne è anzi la prima regola. Se si vuole, la nostra è una continua fuga, ma nello stesso tempo è un continuo attacco. La fuga perciò si spoglia del suo significato vile. Spesso la fuga più immediata permette di aggirare l’attaccante e di colpirlo alle spalle mentre crede ancora di tendere un agguato. Perciò non la chiamiamo fuga questa manovre, né ritirata, ma sganciamento o ripiegamento. Il comandante rotto alla guerriglia lo si riconosce nell’attimo in cui deve decidere se accettare il combattimento o ordinare lo sganciamento. In pochi attimi egli deve valutare un’infinità di cose. Queste nuove regole, ovviamente non piacciono ai militari di carriera. Un colonnello suggeriva qualche tempo fa di costruire su alcune colline bunker e camminamenti. Gli hanno riso in faccia.
Grano (campo di) – Non è altrettanto sicuro, per starvi nascosti, del campo di granturco, ma c’è stato un giorno, indimenticabile, in cui ci siamo rivoltati sulla schiena e abbiamo osservato le spighe, i fiordalisi, i papaveri che tremavano alla brezza estiva e ci siamo accorti che continuavamo a vivere. Di rimando, che spettacolo triste il tappeto di cenere che ne resta dopo un incendio!
Graziani (Maresciello) – Un uomo che sta al Nord, coi tedeschi e del quale si racconta che abbia perso i coglioni in Libia. Così impara a molestare gli arabi!
Inglesi – Da un anno aspettiamo che sferrino l’offensiva, ma non si decidono mai. A differenza degli americani, lanciano armi vecchissime e nessun genere di conforto. Gli inglesi che sono stati paracadutati nelle nostre zone sono però uomini di coraggio, anche se molto diversi da noi. Essi ci rimproverano soprattutto la passionalità e il dilettantismo. Coi loro “Commandos”, sostengono, possono compiere le stesse azioni spericolate delle nostre “volanti”, ma essi calcolano il rischio, noi no.
Lanci – Avvengono quasi sempre di notte, nel punto concordato per radio con gli Alleati e che viene delimitato da grandi falò. Dopo ogni lancio, si portano in giro le armi piovute dal cielo come abiti nuovi, mentre con la seta dei paracadute si confezionano camicie e fazzoletti dai colori più vistosi. Il più grande lancio l’abbiamo avuto la notte dell’Epifania, ma era troppo tardi, eravamo in rotta e circondati da tutte le parti. Con le lacrime agli occhi abbiamo scavato fosse per nascondere le armi che ormai non ci servivano più.
Letto – La stessa cosa che per le donne; se ne parlamolto: «quando tutto sarà finito mi metto a letto e ci resto per un anno», ma poi non si muore a stare senza. L’importante è trovare il tempo e la calma per buttarsi giù; il posto sufficiente per allungare le gambe; e sopra un tetto che non faccia acqua . Nelle foglie si dorme bene., ma al mattino ci si ritrova sudati e fiacchi; la paglia, dal canto suo, non tiene caldo; è sempre preferibile il fieno. Qualcuno è riuscito ad andare a letto con una donna, questa estate: ma, se ne parla, è per rimpiangere il letto più che la donna.
Matteotti – Uno che è morto mentre noi aprivamo gli occhi sul mondo. Se ne dice un gran bene. Nelle foto che abbiamo visto ha gli occhi dei santi- I più anziani fra noi spesso dicono: «Ai tempi di Marreotti», «l’affare Matteotti». Quante poche cose sappiamo intorno a quel periodo, ma ci resta poco tempo per far domande, per discutere, e poi – ora che abbiamo aperto gli occhi sugli errori e i crimini del fascismo – diffidiamo un poco di tutte le altre dottrine- Adesso eliminiamo il fascismo, diciamo, poi si vedrà.
Mitra – Abbreviazione di pistola-mitragliatrice. È una delle parole che identificherà la nostra epoca e la nostra guerriglia in particolare. La più grande ambizionedi una recluta è di buttare via il fucile per un mitra. Ce ne sono di vari tipi, ma il più pratico è lo Sten. Il Beretta è forse più preciso, ma è molto delicato. Quanto al Thompson, è troppo pesante, poi è raro. Serve ai comandanti (come il parabellum russo) quale segno di distinzione. Ha il calibro dodici e un fuoco preciso fino a 4-500 metri. Lo Sten, d contrario, è efficace dentro un raggio di 50-80 metri. E fatto per il corpo a corpo, per l’imboscata- A guardarlo è un catenaccio. Ma non si inceppa mai, anche dopo averlo tenuto sottoterra o nell’acqua. Dicono costi in America meno di un dollaro. Avere un mitra fra le mani non ci si sente più soli; è come se, a sparare, si fosse in dieci. E in fondo è così.
Mongoli – Così la gente chiama i russi che combattono a fianco dei tedeschi, anche se poi non sono affatto mongoli, ma sono soldati sovietici originari dell’Ucraina, del Caucaso, dell’Armenia, del Turkestan.
Forse il primo ad indicarli con questo nome non è stato tanto colpito dai tratti del loro viso, quanto dalla crudeltà delle loro azioni. Più che soldati, infatti, sono predatori, ladri, stupratori, proprio come si dice siano stati i mongoli di Gengis Khan. La loro sorte, d’altronde, è già decisa: essi cadranno sotto i nostri colpi o sotto quelli dei tedeschi, se tenteranno di fuggire, oppure sotto quelli dei russi, se vivranno tanto da tornare in patria. La loro violenza senza limiti è fatta anche dalla consapevolezza di avere i giorni contati.
Montagna – Prima l’identificavamo con l’estate e la villeggiatura, l’inverno e i campi di sci. Era quasi un giocattolo, come il mare. Poi, un giorno, è diventata una scelta. Ed ora è la nostra casa, il nostro letto, il nostro precario rifugio; qualche volta la nostra prigione, la nostra tomba. Altre volte, la più dolce e imprevedibile delle evasioni. Molti giurano che quando tutto sarà finito torneranno per viverci: perché qui hanno ammirato spettacoli e vissuto istanti intraducibili in parole.
Morte – Non se ne parla mai, ma è sempre con noi. Ciascuno si è immaginato la propria, lavorandovi intorno fin dal giorno in cui ha scelto questa parte della barricata. E indispensabile possedere una morte, così come è indispensabile possedere un fucile, un paio di buone scarpe e qualche idea chiara in testa. Sarebbe una sorpresa troppo spiacevole trovarsela dinanzi, all’improvviso, senza essere preparati a riceverla. In ogni caso la si preferisce alle torture e la si augura improvvisa.
Molti portano alla cintura una Sipe (bomba a mano N.d.R.) per essere certi di poter sfuggire alla prigionia. Ogni mattina riattaccandola alla cintura, uno pensa al ferro che gli dilanierà il ventre, e si abitua a questa fine. A poco a poco, tutti si abituano alla propria morte.
Mussolini – Non se parla che raramente. Lui non viene a sparare perciò non conta. È troppo lontano quasi astratto, perché si possa provare il desiderio di ucciderlo. A parlarne di continuo invece sono i più anziani, quelli che per un senso o per l’altro, hanno conti aperti con lui. Perché alcuni lo hanno conosciuto di persona, ed uno gli è stato anche amico quando Mussolini diceva di essere socialista. Essi sono gli unici a figurarsi le possibili morti di Mussolini e se ne hanno a male se noi avanziamo l’ipotesi che egli sfuggirà al castigo e che sarà trasferito in America dentro una gabbia di vetro, come un animale raro. Ai giovani, la sorte di Mussolini non interessa più di quella di Farinacci o di Graziani. Per essi, è come se fosse già morto. Il loro problema è quello di buttar fuori i tedeschi e i loro servitori, e di ripulire il Paese.
Neve – Com’è diversa da quella della nostra infanzia. Nessuno, allora, fabbricando palle di neve, avrebbe sospettato che può portare alla disperazione. Mentre scrivo siamo bloccati in cinque dentro una carbonaia: fuori c’è un metro e mezzo di neve, le piste sono sparite e il più vicino villaggio è a una decina di chilometri. Da due giorni non tocchiamo cibo. Domani dovremo deciderci ad uscire, anche se non avrà cessato di nevicare.
Nome di battaglia – Serve a mascherare la nostra identità e di rimando a tradire il nostro carattere. Esso rivela infatti le nostre ambizioni, o le nostre letture,oppure i limiti della nostra fantasia.
Notte – Ci sono notti brevissime e notti eterne. Quelle passate nei fossi della via Emilia, in attesa di una colonna, con le mani saldate allo Sten non finiscono mai. Le rare in cui puoi dormire durano un amen. «Una notte… ». Ciascuno di noi conserva il ricordo di una notte terribile.
Paga – Una volta, e fu l’ultima, al principio della estate, distribuirono trecento lire a ciascuno di noi. «Chi li manda questi soldi?» uno domandò. Il furiere rispose: «Non so, credo gli americani». Quegli allora ribatté: «Non siamo al servizio degli americani», e restituì i soldi. Alcuni lo imitarono.
Partigiani – Ce ne sono di tutti i tipi: comunisti e cattolici, socialisti e liberali, anarchici e trotzkisti, giellisti e monarchici, leali e opportunisti, coraggiosi e vigliacchi, decisi e attendisti, generosi e scaltri, onesti e ladri, giovani e vecchi, eroi e doppiogiochisti, consapevoli e no, con scarpe e senza scarpe, vestiti come soldati e come pagliacci. Combattono una delle diecimila guerre che l’uomo ha scatenato su questa terra e pensano di essere dalla parte della ragione.
Paura – Chi dice di non averne è un bugiardo. Nessuno di noi può giurare che sarà vivo domani. O anche stasera.
Pianura – Ci andiamo spesso, ma come ladri, di notte. E ormai, abituati come siamo a vedere le cose dall’alto dei monti, abbiamo paura del suo orizzonte limitato e piatto- Un giorno l’attraverseremo con la luce del sole e sarà l’ultimo giorno di guerra.
Pippo – Con questo nome indichiamo l’aereo che vaga tutte le notti e lancia bombe a casaccio, su noi e sugli altri. Il suo non sembra un rumore di motori, ma l’ansito di un mostruoso animale. E fin che il battito delle sue ali non si si affievolisce tratteniamo il respiro.
Politica – I giovani non amano e non sanno farne. I più anziani la preferiscono alle azioni di guerra.
Ponti – In qualche valle non ne è rimasto uno. Li abbiamo fatti saltare tutti: quegli antichi in mattoni, quelli in pietra, quelli in ferro, quelli in cemento armato. Ma a che è servito? I tedeschi gettano un ponte in dieci ore. Quella che avremmo dovuto far saltare è la kommandantur.
Prete – Quello che sta con noi è l’umile e povero parroco di campagna. Gli alti prelati, in città, benedicono i gagliardetti delle “Brigate Nere”.
Raffica – Una parola, come mitra, in cui si concentrano l’odio e la violenza. Una parola di questa guerra. La raffica, per eccellenza, è del mitra ed è breve, esce dalla canna corta senza strappi e qualche volta l’uomo che spara riesce a vedere negli occhi l’altro che insacca i colpi.
Rappresaglia – Un’invenzione degli “altri” che qualche volta siamo costretti ad adottare. Il mongolo Elia, sfuggito ai tedeschi e da noi graziato, ci suggerisce: «Se volete spaventare i tedeschi, decapitate i prigionieri e andate portate le loro teste davanti alle caserme della città » E ride quando nota il nostro imbarazzo, «Voiitaliani – soggiunge, – siete capaci di uccidere soltantoper gelosia».
Repubblica – Una parola che può significare la parte avversa. Esempio: «Arriva la repubblica». Oppure una straordinaria confusione: «Che repubblica!». Chissà quanti anni occorreranno, da noi, perché riacquisti il suo vero significato.
Repubblichini – Se ne stanno in città, preferibilmente al sicuro, con le scarpe lustre, il ciuffo fuori del berretto. Quando vengono in rastrellamento, si fanno precedere dai tedeschi. Quando le buscano, i tedeschi li tolgono dai guai. Ci sono vari tipi di repubblichini. I vecchi fascisti delle squadracce. Quelli che si ritengono disonorati dall’armistizio. I filotedeschi. Quelli che spasimano per le cause perse. Quelli che vanno sempre controcorrente. Quelli che desiderano semplicemente un’arma per sparare (ce ne sono molti anche dalla nostra parte). Quelli che sperano di arricchire. Quelli che hanno risposto ai bandi e che ora non trovano il coraggio di scappare . I razzisti. Gli spavaldi. Gli isterici. Gli stupidi. Quelli della “Muti” e delle “Brigate Nere” sono i più arrabbiati (e anche i più vigliacchi); quelli della “Decima” credono di appartenere ad un corpo scelto e amano dare spettacolo (aiutati dalle loro divise da operetta); agli alpini della “Monterosa” e ai bersaglieri dell’”Italia” hanno insegnato a combattere in Germania, in modo perfetto, ma la loro idea fissa è quella di scappare. Chi li ha battezzati “repubblichini” meriterebbe una statua.
Non c’è espressione, infatti, che meglio dipinga la loro pochezza e viltà e goffaggine
Scarpe – E il nostro dramma; si consumano in un amen. Chiediamo scusai ai morti se li spogliamo ma noi dobbiamo continuare a camminare e loro hanno finito.
Silenzio – C’è il silenzio della notte, che fa pensare all’inganno. C’è il silenzio dell’alba, che intristisce. Ma il più crudele è il silenzio che precede la raffica nell’imboscata.
Sipe – Quando scoppia, lancia intorno ottantaquattro schegge tutte uguali ottantaquattro cubetti di ghisa. Un maggiore della missione inglese, per non cadere prigioniero, si è buttato sopra una Sipe dopo aver tolto la sicurezza. Quasi tutti, adesso, appesa alla cinghia portano una Sipe.
Spia – Nel Paese in cui viviamo, diviso dalla guerra civile, tutti lo possono essere. Un tale che veniva da noi a mendicare pane, ha venduto per duecento lire la vita di quindici nostri compagni. Per questo siamo spietati con le spie, anche a rischio di cadere in errori.
Tedeschi – Adesso, noi che ce li siamo trovati di fronte più volte, sappiamo che non sono invincibili. Ma le reclute si lasciano ancora impressionare da quella corta giacchetta, dalla forma dell’elmo, dagli stivaletti, dal modo di correre all’assalto. È consigliabile catturarne alcuni e tenerli all’accampamento, impiegandoli nei lavori più umili. Le reclute finiscono così per accorgersi che sono esseri umani, coraggiosi e vili come gli uomini di tutto il mondo.
Vittorio Emanuele – Era piccolo col fascismo. Senza fascismo non è cresciuto di un pollice.
Volante – Non si sa chi abbia dato questo nome al piccolo gruppo di uomini che, agendo di sorpresa, attacca gli automezzi sulle grandi vie di comunicazione, fa saltare depositi e binari e, se occorre per uno scambio di prigionieri, preleva anche un generale tedesco dal suo stesso ufficio. Non è improbabile che a coniare questo termine sia stato uno che ha partecipato alla guerra di Spagna. È impressionante il bagaglio di esperienze, di nomi, di immagini, di tradizioni che ci viene da quella sfortunata guerra per la libertà.
Con questa voce terminava il dizionario, scritto con la stessa calligrafia rotonda, educata; si sarebbe detto di un insegnante elementare. Lo esaminammo in tutti gli angoli, ma non portava firma. Mancavano anche, nel testo, riferimenti personali che potessero aiutarci ad identificarne l’autore. L’unico era contenuto nella voce “Never”, che faceva cenno, in termini asciutti ma sufficientemente drammatici, alla sosta forzata nella carbonaia. Ma era un’indicazione troppo vaga. Fra il dicembre e il febbraio a moltissimi era accaduto di rimanere bloccati dalla neve per uno o più giorni; e c’erano parecchie centinaia di carbonaie scavate nella montagna.
Constatammo, oltretutto, che questo riferimento doveva essere considerato come un’indicazione involontaria, con ogni probabilità l’effetto di un momentaneo turbamento. Soltanto nell’avvertire che si stava avvicinando la fine l’anonimo partigiano si era abbandonato a narrare i prima persona. Ma a questa debolezza aveva subito rimediato con un gesto che può essere soltanto suggerito dalla serenità e da una certa abitudine all’ordine. Trovammo infatti il foglietto con la voce “Neve” rimesso diligentemente al suo posto, fra la voce “Mussolini” e quella che riguarda la “Notte”.
 Il 18 gennaio 1943 gli ebrei del Ghetto di Varsavia occupata dai nazisti reagirono per la prima volta alle le violenze e le deportazioni, che riuscirono a impedire resistendo ai tedeschi. Il comandante delle SS ordinò la distruzione del Ghetto, i cui abitanti organizzarono una rivolta che tenne in scacco i nazisti per un mese tra aprile e maggio, prima che il Ghetto fosse raso al suolo e la rivolta si concludesse con l’uccisione di oltre diecimila ebrei e la deportazione di circa 50 mila. Questa la storia della rivolta:
Il 18 gennaio 1943 gli ebrei del Ghetto di Varsavia occupata dai nazisti reagirono per la prima volta alle le violenze e le deportazioni, che riuscirono a impedire resistendo ai tedeschi. Il comandante delle SS ordinò la distruzione del Ghetto, i cui abitanti organizzarono una rivolta che tenne in scacco i nazisti per un mese tra aprile e maggio, prima che il Ghetto fosse raso al suolo e la rivolta si concludesse con l’uccisione di oltre diecimila ebrei e la deportazione di circa 50 mila. Questa la storia della rivolta: