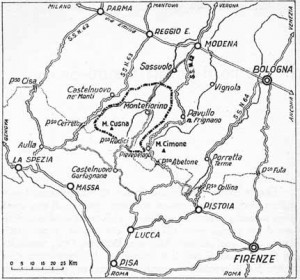Il 10 Agosto 1944, su ordine degli occupanti nazisti, la Legione Muti fucilò in Piazzale Loreto a Milano 15 partigiani lasciando i corpi esposti al calore ed alle mosche per l’intera giornata. Nell’Agosto del ’44 Milano è sotto occupazione nazista da ormai quasi un anno. Pochi giorni dopo l’armistizio dell’8 Settembre nel quadro dell’occupazione nazista dell’Italia, tesa a rallentare l’avanzata degli Alleati a Sud ed a garantire l’esistenza della Repubblica Sociale Italiana, la città è stata occupata dalla tristemente nota divisione Waffen-SS Leibstandarte SS Adolf Hitler.
Il 10 Agosto 1944, su ordine degli occupanti nazisti, la Legione Muti fucilò in Piazzale Loreto a Milano 15 partigiani lasciando i corpi esposti al calore ed alle mosche per l’intera giornata. Nell’Agosto del ’44 Milano è sotto occupazione nazista da ormai quasi un anno. Pochi giorni dopo l’armistizio dell’8 Settembre nel quadro dell’occupazione nazista dell’Italia, tesa a rallentare l’avanzata degli Alleati a Sud ed a garantire l’esistenza della Repubblica Sociale Italiana, la città è stata occupata dalla tristemente nota divisione Waffen-SS Leibstandarte SS Adolf Hitler.
Milano era già stata teatro degli scioperi del 1943 e del 1944, che erano costati la deportazione di moltissimi operai e di molte azioni partigiane tra la quali l’assalto all’aeroporto di Taliedo, l’eliminazione del Federale di Milano Aldo Rasega, l’assalto alla Casa del Fascio di Sesto San Giovanni e tante altre. La reazione nazista e fascista fu dura con rastrellamenti e deportazioni di massa. Nel Dicembre del ’43 tra l’Arena ed il Poligono di Milano vennero fucilati 13 partigiani.
Nel Febbraio del 1945 il movimento partigiano riprese forza anche grazie all’arrivo da Torino del Comandante Visone, Giovanni Pesce. A Giugno, in fuga da Roma liberata dagli Alleati, giunsero a Milano i tristemente noti torturatori fascisti della Banda Koch che si insediarono presso la Villa Fossati in Via Paolo Uccello.
Il mesi di Luglio ed Agosto videro una recrudescenza repressiva con diverse fucilazioni di partigiani in città ed in provincia.
Del resto, tra il 21 Luglio e il 25 Settembre 1944 i Tedeschi lamentarono 624 caduti, 993 feriti e 872 dispersi a causa di attacchi della Resistenza che, a propria volta, ebbe nello stesso periodo 9250 caduti. Questo poneva la Resistenza italiana ai primi posti come livello di efficienza solo dietro a quella sovietica ed a quella jugoslava. Il 10 Agosto su ordine del Comando della Sicurezza (SD) tedesca a Milano furono prelevati da San Vittore 15 partigiani. La loro fucilazione avvenne all’alba.
I nazisti, al comando del capitano delle SS Theodor Saevecke, giustificarono la strage come risposta all’attentato contro un camion tedesco avvenuto in Viale Abruzzi l’8 Agosto 1944. Quell’attentato, mai rivendicato, non fece alcuna vittima tra i Tedeschi.
Si trattò quindi di un’operazione di puro terrore poiché il famigerato Bando Kesselring (comandante delle truppe tedesche in Italia) prevedeva la fucilazione di 10 Italiani per ogni soldato tedesco caduto. I corpi, lasciati esposti per l’intera giornata ed insultati dai militi della Muti furono rimossi solo in serata.
Questo feroce episodio aumentò a dismisura l’odio ed il risentimento dei Milanesi contro tedeschi e fascisti.
Questi i nomi dei 15:
–Gian Antonio Bravin, 36 anni
–Giulio Casiraghi, 44 anni
–Renzo del Riccio, 20 anni
–Andrea Esposito, 45 anni
–Domenico Fiorani, 31 anni
–Umberto Fogagnolo, 42 anni
–Tullio Galimberti, 21 anni
–Vittorio Gasparini, 31 anni
–Emidio Mastrodomenico, 21 anni
–Angelo Poletti, 32 anni
–Salvatore Principato, 51 anni
–Andrea Ragni, 22 anni
–Eraldo Soncini, 43 anni
–Libero Temolo, 37 anni
–Vitale Vertemati, 26 anni
Questo è un brano dell’ultima lettera di Umberto Fogagnolo alla moglie:
“Ho vissuto ore febbrili ed ho giocato il tutto per tutto. Per i nostri figli e per il tuo avvenire è bene tu sia al corrente di tutto. Qui ho organizzato la massa operaia che ora dirigo verso un fine che io credo santo e giusto. Tu Nadina mi perdonerai se oggi gioco la mia vita. Di una cosa però è bene che tu sia certa. Ed è che io sempre e soprattutto penso ed amo te e i nostri figli. V’è nella vita di ogni uomo però un momento decisivo nel quale chi ha vissuto per un ideale deve decidere ed abbandonare le parole”